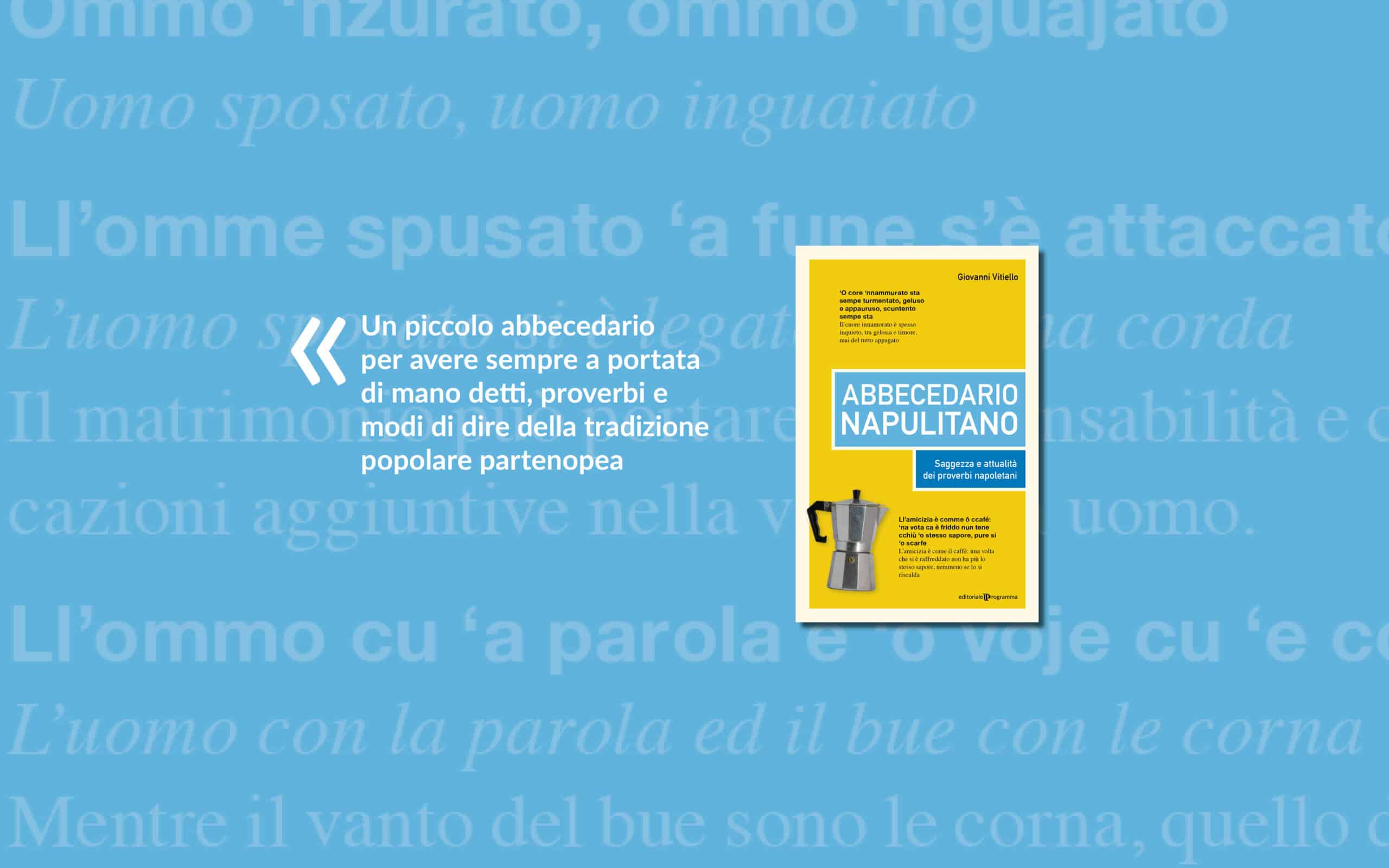Così viene tradotto in napoletano il detto francese “Après Paque est fète encore”.
I Napoletani, si sa, hanno subito in epoche diverse la dominazione francese, ma il francese lo utilizzano a modo loro. La parola Pasqua ha una derivazione complessa, che dopo aver coinvolto l’ebraico biblico, l’aramaico e il greco, arriva alla Pèsach o Pesah (Pasqua ebraica, che dura otto giorni – sette ad Israele -) che ricorda la liberazione del popolo ebraico dall’Egitto e il suo esodo verso la Terra Promessa.
Il nome latino Pascha, evoca anche la liberazione dalla schiavitù in Egitto degli Ebrei, che, fuggendo, per sette si nutrirono con pane di spighe d’orzo raccolte lungo il percorso e non lievitate (ancora oggi festeggiato come <Festa dei Pani Azzimi).
La pesach segna il principio della primavera, è una delle tre “feste di pellegrinaggio” (Chag haaviv, losh e Sukkot) ed è anche chiamata, cioè, “festa della primavera”. La spiegazione? Gesù era l’ebreo di Nazareth e osservava le feste del calendario ebraico come tutti gli ebrei del suo tempo, per questo motivo, la Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana hanno molti punti in comune tra di loro.
Gesù salì a Gerusalemme al tempo della Pasqua e la sua ultima cena con i discepoli è descritta nei vangeli sinottici come una cena pasquale. Il sacrificio dell’agnello pasquale ha delle connessioni con la sua morte sulla croce (in modo particolare nel Vangelo di San Giovanni): secondo la Bibbia, gli Ebrei furono incaricati di sacrificare un agnello e utilizzare il suo sangue per pennellare gli stipiti delle porte in modo che le forze del bene potessero oltrepassarle senza fermarsi. Simbolicamente, Cristo è diventato l’Agnello immolato per salvare l’umanità dai suoi peccati.
I Napoletani, dopo i festeggiamenti pasquali, festeggiano la Pasquetta che dovrebbe ricordare l’incontro dell’angelo con le donne giunte al sepolcro. Ma, in realtà, oggi ben pochi lo sanno: la Pasquetta, è soltanto un giorno festivo che si trascorre all’aria aperta, in modo libero e allegro.
Invece, il detto “Aroppo Pasqua fete ancora“, a Napoli indica soltanto una data, oltre la quale chi non è una persona corretta continua ad esserlo (fete ancora), diventando insopportabile. Si gioca sull’equivoco tra il termine “fête“, che assume il significato di puzza, (dal latino “foetēre“, puzzare): in sostanza, la festa continua, ma all’aria aperta.
E… se piove?? Aspettammo ca schiove, tanto … è fète encore!
Fonti
Pagina Facebook Etimologia delle parole napoletane
(da un mio vecchio post)