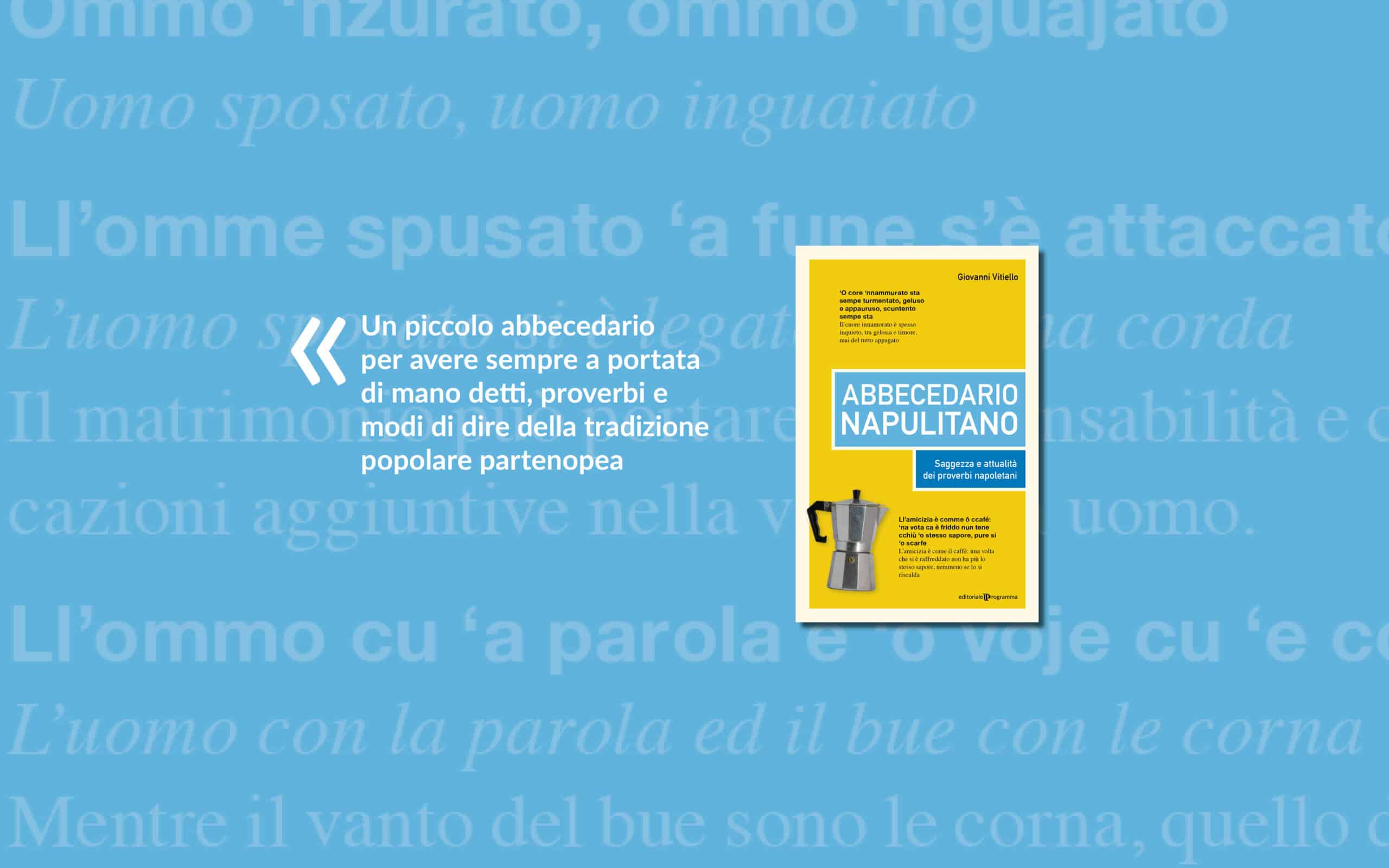Premesso che gastronomia (dal greco γαστήρ (ventre) e νόμος (legge)) è l’insieme delle tecniche e delle prescrizioni utilizzate in cucina, cominciamo dai tempi lontani, quando le ricette casalinghe passavano di casa in casa; i prontuari, invece, erano destinati alla “cucina dei Re”, opera di cuochi (esclusivamente di genere maschile) che lavoravano presso le grandi corti e nei conventi.
Per trovare tracce della loro effettiva presenza a Napoli, dobbiamo arrivare al ‘700 e ai Monsù (francesi, come attesta il loro appellativo generico, derivato da “Monsieur”), chiamati alla Corte napoletana per compiacere i gusti ricercati della Regina Maria Carolina d’Austria, in perenne rivalità con la sorella Maria Antonietta: nacquero così molte ricette ricche di sapori e presentate in modo spettacolare come il ragù (da ragout), il gattò (da gateau), i crocchè (da croquettes), i supplì, e il timpàno (dal latino tympan, per la sua somiglianza con l’apparato auricolare), che al centro nascondeva un mezzo guscio d’uovo con un po’ di alcool cui veniva dato fuoco al momento di servire a tavola, in ricordo del Vesuvio.
Per trovare tracce della loro effettiva presenza a Napoli, dobbiamo arrivare al ‘700 e ai Monsù (francesi, come attesta il loro appellativo generico, derivato da “Monsieur”), chiamati alla Corte napoletana per compiacere i gusti ricercati della Regina Maria Carolina d’Austria, in perenne rivalità con la sorella Maria Antonietta: nacquero così molte ricette ricche di sapori e presentate in modo spettacolare come il ragù (da ragout), il gattò (da gateau), i crocchè (da croquettes), i supplì, e il timpàno (dal latino tympan, per la sua somiglianza con l’apparato auricolare), che al centro nascondeva un mezzo guscio d’uovo con un po’ di alcool cui veniva dato fuoco al momento di servire a tavola, in ricordo del Vesuvio.
Il timpano, detto anche sartù ((letteralmente “su tutto”, con riferimento allo speciale “mantello” di pangrattato di copertura, era preparato con il riso, che già da tempo era arrivato a Napoli dalla Spagna: lo avevano introdotto alla fine del XIV gli Aragonesi, ma i Napoletani non era piaciuto: delicato al punto da apparire insapore, a corte veniva chiamato “sciacquapanza“.
Così per ripiego, era stato utilizzato dalla Scuola di Medicina Salernitana per curare le malattie intestinali o gastriche. Fu nel XIX secolo che nelle corti nobiliari di Napoli si diffusero le maestranze culinarie e uno dei più famosi fu Vincenzo Corrado, capo dei sevizi di bocca per il Principe di Francavilla di Palazzo Cellamare: “Il cuoco galante” è il compendio che raccoglie le sue ricette, simbolo della cucina aristocratica del tempo e fu anche il primo interprete del gusto autentico della “cucina mediterranea”.
Aiutato da sottocuochi, maggiordomi, domestici e paggi, preparava sontuosi e scenografici pranzi e cene prevedevano un grande assortimento di vivande accoppiate con fantasia e serviti con una coreografia sontuosa e raffinata; oltre al testo già citato, fu autore de “Il Credenziere di buon gusto” (1778) e dedicò ai vegetariani “Del Cibo Pitagorico, ovvero Erbaceo per uso de’ nobili e de’ letterati” (1781).
Ancora oggi la “cucina dei Monsù” è citata per le sue qualità̀ e capacità di trasferire il gusto elaborato piatti della tradizione francese nei piatti locali: in essi, in apparenza molti semplici, permangono essenze e sapori di influenze arabe e spagnole, di spezie mediterranee, di contrasti agro-dolci, di intingoli che nobilitano la plebea “mmesca francesca“.
La “summa” di tutta la cucina napoletana: ‘E vermicielle agglio e uoglio
Questo piatto comparve nelle campagne napoletane tra la fine del ‘500 e il ‘600, ma si diffuse alla corte borbonica nell‘800. Ippolito Cavalcanti, nel suo libro “Cucina Teorico Pratica” pubblicato a Napoli nel 1837, scrive: “Lesserai pronti pronti, libbre quattro di vermicelli, li sgocciolerai e frattanto farai soffriggere in una casseruola once sei d’oglio ottimo, con due spicchi di aglio”.
La ricetta originaria, dunque, non comprendeva il peperoncino all’epoca confinato ad alcune regioni del Mezzogiorno (Calabria, Puglia Basilicata, Molise) e costituisce un’aggiunta più recente, che fa da complemento all’uso degli spaghetti al posto dei vermicelli.
Diffusasi come “Vermicielle alla borbonica”, fu definita da Eduardo “Spaghetti alle vongole fujute”, perché il suo gusto non è inferiore a quello del tradizionale e ricco “spaghetto a vongole”, sebbene il suo costo sia di gran lunga inferiore: oggi, la sua semplice ricetta non manca in nessun ricettario nazionale, essendo stata eletta a pietanza conviviale per eccellenza, con piccole varianti locali, perdonate anche dai Napoletani); l’importante è saltare la pasta in padella nell’aglio, olio e peperoncino, gustarla come primo piatto o, come qualche volta capita, portarla a fine cena come “digestivo”.
Nota su spaghetti e vermicielle
La teoria più accorsata vuole che gli spaghetti siano stati importati da Marco Polo dopo il suo viaggio in Cina e Pakistan, ma sicuramente è nel nostro meridione che si è perfezionato il loro processo di essiccazione. Il loro consumo è stato a lungo legato al nostro meridione: nati come prodotto di scaro della lavorazione delle paste, per la loro economicità conquistarono subito le famiglie più indigenti nascono come un cibo di seconda scelta. Pare infatti che fossero inizialmente un semplice prodotto di scarto della lavorazione pastaria, ragion per cui non era considerato un cibo pregiato.
La storia degli spaghetti conosce, nel corso degli anni, la popolazione più povera, quella che coltiva frumento.
Una storia etimologica e un detto
Secondo una leggenda il nome di questa pasta deriverebbe da “siphae“, ossia soldati soldati del regno ottomano il cui nome iniziale si trasformò poi in “spahi“, termine italianizzato in spaghetti.
Molto più probabile, a pare mio, è che derivi dal latino volgare spacus, a sua volta dal greco σπάγκος, spacus, o dall’arabo espab, sempre con il significato di fune
Fonti
Dalla pagina Facebook Etimologia delle parole napoletane
Immagine: un “timpano”, condotto auricolare.