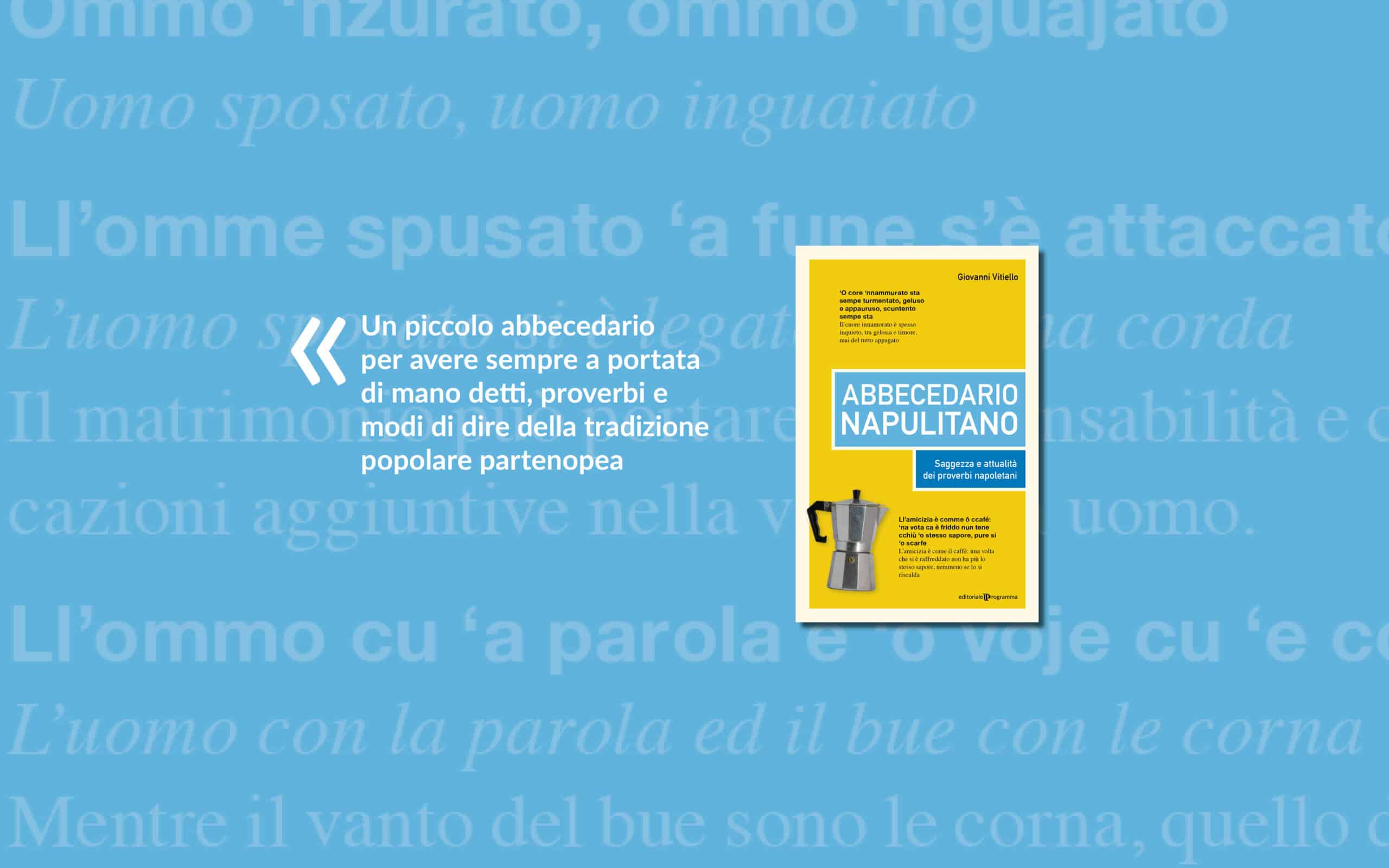“Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male” (Eduardo dixit)
Strano e celeberrimo in tutti i luoghi principali dell’antichità mediterranea, il piccolo e barbuto Priapo dotato di un fallo enorme: il primo mito che lo riguarda narra la storia di Crono, che divorava i figli non appena venivano partoriti dalla moglie Ρέα- Rea, perché nessuno potesse detronizzarlo.
Rea ingannò il marito e riuscì a nascondere Zeus, il suo ultimogenito: il piccolo fu nutrito dal latte della capra capra/ninfa Ἀμάλθεια, Amaltea, che lo custodì in una culla dorata appesa ai rami di un albero.
Quando Zeus divenne grande, per ringraziare Amaltea creò per lei la costellazione del Capricorno (“corno della capra”). Da quel corno si originò la prodigiosa “cornucopia” che era il simbolo dell’abbondanza: la cornucopia più antica è quella della statua del Nilo al Largo Corpo di Napoli a Spaccanapoli.
Altro mito greco narra che invece si tratti di Priapo, nato da un rapporto incestuoso tra Afrodite e il padre Zeus: la consorte Giunone, per punire i due, aveva trasformato il piccolo in un personaggio osceno, dai potenti (ed evidenti) istinti sessuale.
Nella ricca Pompei greco-romana, molto più raffinata rispetto al vicino capoluogo partenopeo, il problema dell’origine del dio importava poco: era invece importante l’aspetto economico – attestato dalla scritta in molti edifici pubblici e nella casa del commerciante Vedio Sirico: SALVE LVCRV (M) -, cioè <Benvenuto guadagno>: chi si arricchiva era protetto non solo da Mercurio, ma anche da Priapo. Nell’antica Roma una preghiera anonima recita: <Salve Priapo, Padre fecondo, di orti custode, violatore/ Ti invoco, rubizzo, dissipatore spermatico/ Tu che semini la vita).
Il culto continuò anche dopo l’avvento del cattolicesimo come sembrerebbe attestare una misteriosa e molto discussa stele di marmo nelle Catacombe di San Gennaro; i napoletani, da sempre, evocano il dio pagano con l’espressione allusiva dedicata a due litiganti: Stanne verenno chi ‘o tene cchiù gruosso.
Ma non solo: lo hanno trasformato in un corno di proporzioni variabili, ma sempre ritorto e rosso da portare sempre con sé, sfregandolo per incitarne l’azione e procurare la buona sorte.
Tradizionalmente rosso, ‘o cuorno/curniciello è amuleto si è diffuso soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia, ma la sua vera patria è Napoli.
Perché, se possiamo trovare ancestrali e simili divinità in tutte le antiche divinità dai Sumeri, ai Cinesi, dagli Sciamani ai Siberiani, e nella realtà e nella cultura partenopea che da sempre convivono pacificamente credi religiosi e superstizione, e si sfrega ‘o cuorno pe scaccià ‘o maluocchio, po’ se va a pregà ‘o Pateterno …
‘O cuorno/curnetto napulitano ha ispirato canzoni e macchiette, è il souvenir più venduto, sin dall’antichità è stato riprodotto in oreficeria in corallo e oro. artistico che ha ispirato orafi sin dall’antichità. nella nostra città
Per la sua forma, il corno napoletano rappresenta anche il fallo di Priapo, il dio della fortuna e della fertilità, come testimoniano i ritrovamenti di numerosi oggetti del genere negli scavi di Pompei ed Ercolano.
Nel medioevo al corno si attribuirono proprietà magiche e diventò ufficialmente l’amuleto più efficace contro l’influenza maligna. Il corno rappresenta uno dei simboli più importanti della nostra cultura popolare, ma perché porti veramente fortuna, devono essere rispettate alcune caratteristiche. Prima di tutto deve essere Tuosto, vacante, stuorto e cu ‘a ponta; poi deve essere rigorosamente fatto a mano, in modo che l’artigiano riesca a trasmettere le sue influenze positive nell’oggetto; deve essere rosso, perché rosso è il colore del sangue, quindi della vita stessa.
Sembra che ‘o curniciello abbia preso la prima ispirazione dal peperoncino piccante, simile per forma e dimensioni al corno “tascabile” di buon auspicio.
Ultima regola, ma forse più importante: ‘o curnicello deve essere stato ricevuto in dono; non va mai comprato dalla persona cui è destinato, perché solo così potrà avere i suoi effetti benefici.
Un’antica prece medievale recita: “San Gennaro, san Girolamo, san Crispino, san Giustino usa il mio cornetto, dagli fuoco, dagli vento. San Gennaro, san Girolamo, usa il mio cornetto. San Crispino, san Giustino, fammi vincere il quattrino. Sant’Eufemia, Sant’Assunta, non tremate nell’aggiunta. Nel borsello il mio quattrino, il cornetto al santino”.
Nota etimologica
Cuorno deriva dal neutro latino cornu (pl. cornua); da esso, come afferma Raffaele Bracale, deriva anche il termine napoletano “scuorno“, in cui la “s” iniziale indica la perdita cioè la durezza del corno.
Come i cervi, che perdono nelle battaglie per le femmine quando sono “scornati”, così i napoletani sono svergognati, messi in ridicolo, derisi, quando perdono la loro durezza.
Quanto all’accostamento del peperoncino rosso al corno, i cibi piccanti in genere sono mantengono alto il livello di testosterone: il peperoncino, dunque, oltre a essere afrodisiaco, indicherebbe con chiarezza i veri “maschi alfa”.
Altra espressione che richiama alla durezza è Tenè ‘na faccia ’e cuorno (detto di chi non si scompone, di chi è impudente) E anche questo ci riporta all’origine fallica.
Fonti
Pagina Facebook Etimologia delle parole napoletane
Da un mio vecchio post, Raffaele Bracale, identità insorgenti.com, Vesuvio live, Wikipedia et Al., modificati; la definizione del titolo è del grande Eduardo;
Immagine: Statua del dio Nilo, Wikimedia)
Immagine: Statua del dio Nilo, Wikimedia)