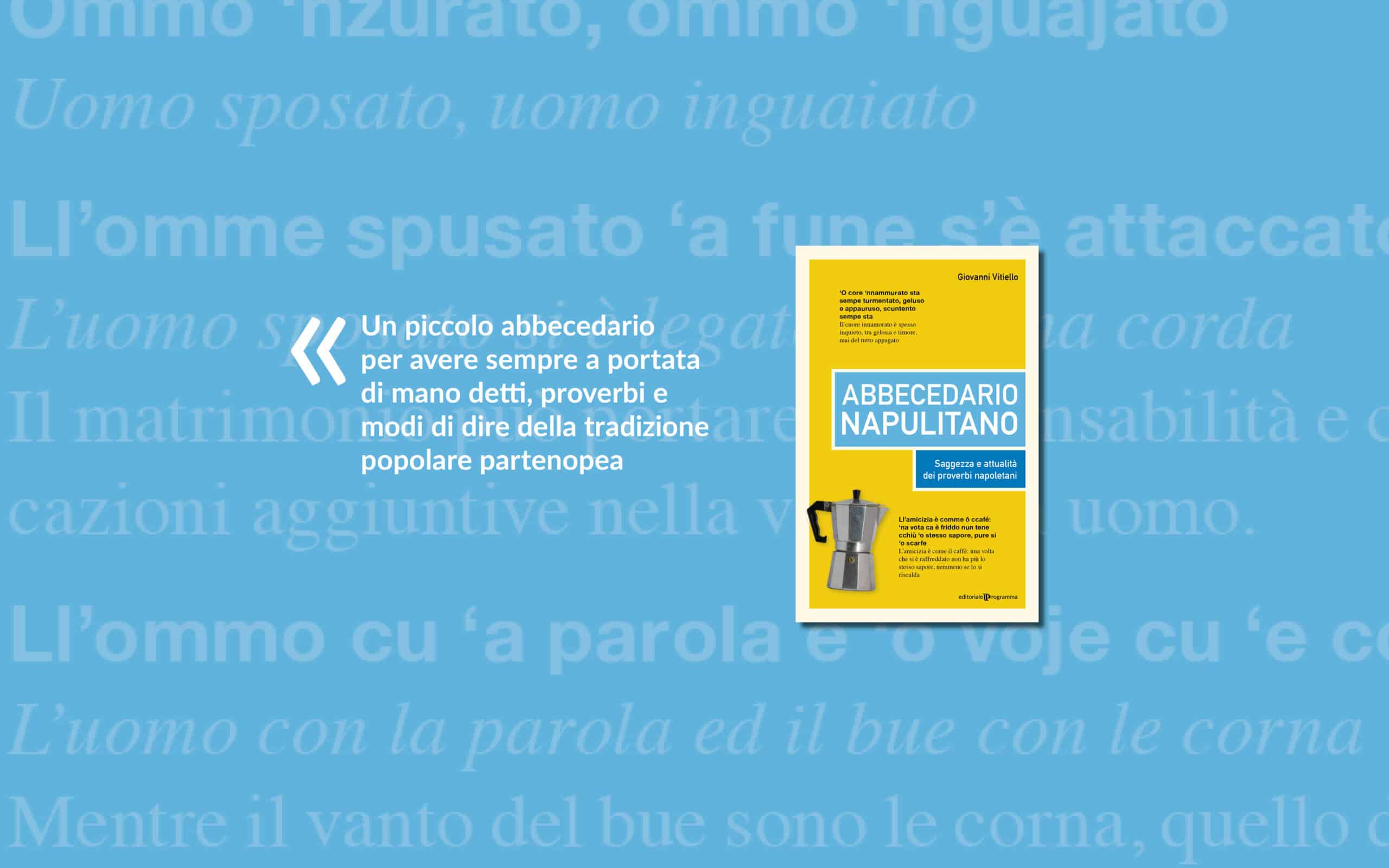Premessa
Il termine in sé non costituisce un semplice diminutivo del termine “Santa”, che in italiano ha il significato di “sacra” o “santa”. Il suffisso, infatti, tipicamente napoletano, non è un modo affettuoso di definire una persona duale nei comportamenti: da un lato timida e timorata di Dio, dall’altro estrosa e volutamente ribelle alle consuetudini radicate nella società.
Angelo e si muove in un contesto zeppo di ipocrisie, in una società che nasconde i propri vizi e si ammanta di virtù, cercando in tutti i modo nuove sensazioni e nuovi peccati.
Tutto ciò avviene – grazie alla magistrale e sorridente arte scenica scarpettiana – senza drammi apparenti, ma i desideri, le vanità e anche i pericoli insiti in atteggiamenti pericolosi e intriganti lambiscono l’immoralità di un secolo – il Novecento – pieno di contraddizioni; ma lo fanno con plausibili, creativi e/o terapeutici e risolutivi , che colpiscono gli spettatori per la loro efficace ambiguità.
La trama
Felice Sciosciammocca è un personaggio bivalente: di giorno, suona musiche sacre come organista in un convento e insegna musica alle educande; di notte, invece, di nascosto delle monache, si reca a Napoli dove, sotto i l nome falso di si dedica a comporre operette (ai suoi tempi considerate peccaminose).
La furba educanda Nannina, detta, per i suoi ipocriti e forzati atteggiamenti religiosi, “Santarella”, scopre la doppia vita di Felice; e quando viene costretta a seguirlo a Roma per combinare le sue, lo ricatta minacciando che se non la condurrà al Teatro romano dove è messa in scena un’operetta, “La figlia dell’imperatore“, rivelerà alle monache la sua attività di autore e compositore di commedie musicali, considerate all’epoca . La commedia ha un lieto fine: Felice sposerà la sua innamorata di sempre (Cesira); ‘a Santarella si innamorerà e sposerà proprio colui a cui era stata – per volere delle monache – destinata in moglie, cioè Eugenio Poretti.
Il successo enorme della commedia – ricca di frizzi e lazzi – procurò a Scarpetta una tale mole di proventi da consentirli la costruzione di una villa al Vomero che chiamò, appunto, Santarella: la struttura, in stile Liberty napoletano fu costruito come un piccolo castello, in stile neorinascimentale: di forma squadrata con agli angoli quattro torrette sporgenti e merlate, (Scarpetta la definì “‘nu cummò sotto e ‘ncoppa!“”) e sulla facciata fece scrivere: “Qui rido io” perché costruita a spesa delle risate del suo pubblico e destinata ad accogliere le risate del suo autore!
Nota stradale
Il Comune di Napoli chiamò così anche la strada che portava alla villa Viale Santarella; nome utilizzato ancora oggi, nonostante la via si chiami attualmente via Luigia Sanfelice…
Curiosità
In realtà Scarpetta si ispirò (e dichiarò pubblicamente) di essersi ispirato ad un’operette francese, di Louis Auguste Joseph Florimond Ronger in arte Hervé su libretto di Henri Meilhac e Albert Millaud che fu rappresentata per la prima volta al Théâtre des Variétés di Parigi il 26 gennaio 1883.
Scarpetta, ne conservò la trama ma cambiò completamente l’ambientazione e le battute.
Fonti
Pagina Facebook Etimologia delle parole napoletane
(Da alcuni miei vecchi post, rivisitati, a cui rimando per le notazioni bibliografiche; l’immagine: la villa, Wikipedia)