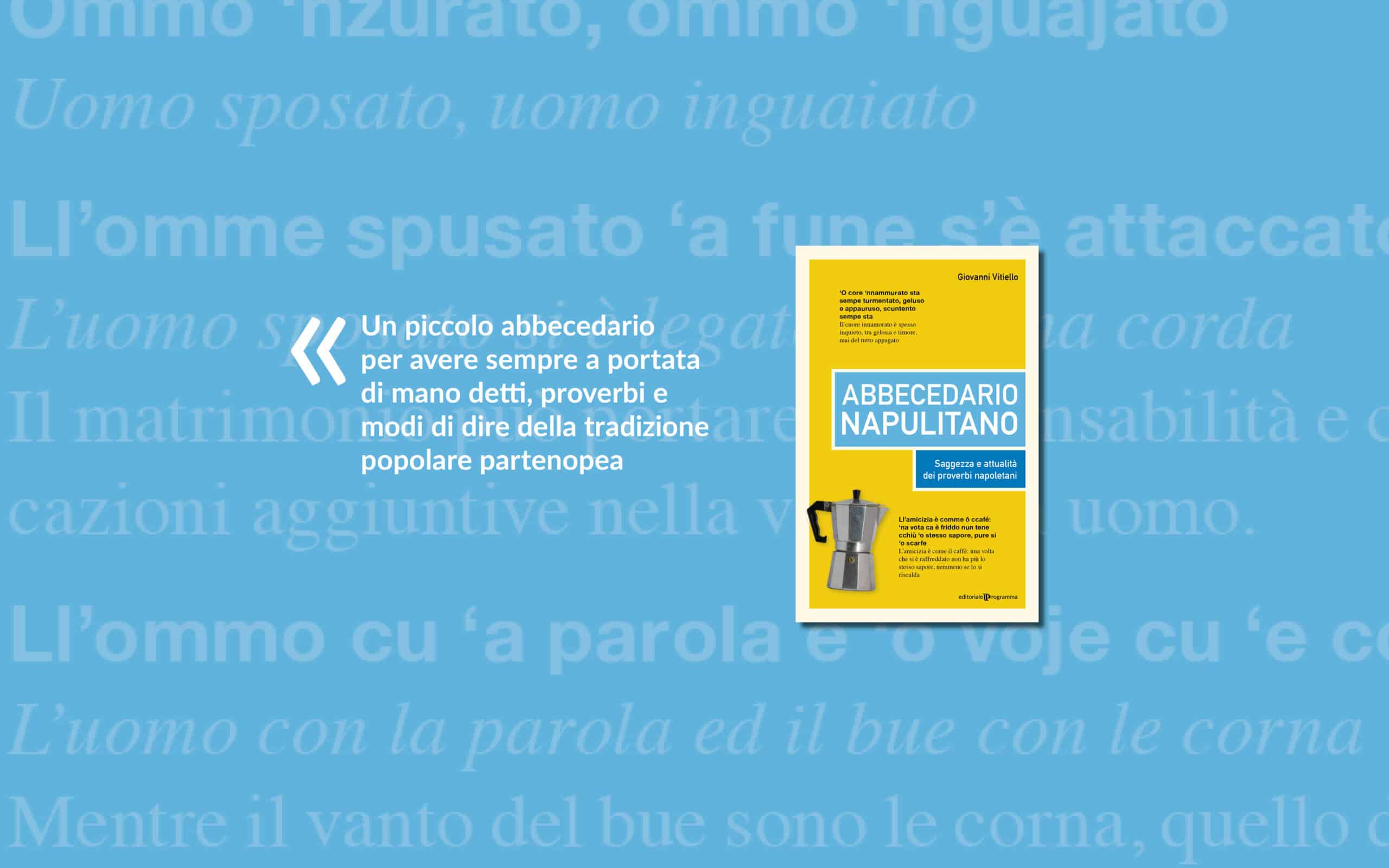*Nella frenetica (e spesso inutile) vita di oggi, spesso, percorrendo le strade cittadine, neppure vediamo quello che abbiamo sotto gli occhi, nonostante abbia una lunga storia da raccontarci: un esempio? La Villa Comunale e la sua fontana.
Un tempo lontano, l’area in questione – oggi lambita da un traffico veloce e miope – era una vasta “chiaja” (spiaggia, dal latino “plaga“, attraverso il catalano “platja” e il castigliano “playa”, nomi arrivati a Napoli durante le dominazioni aragonese e spagnola); Chiaja / Chiaia è oggi il nome del quartiere fortemente urbanizzato.
La lunga spiaggia di Chiaja fu la maggiore risorsa turistica tra il 700 e l’800: era il luogo dal quale i napoletani e i viaggiatori del Grand Tour ammiravano le spettacolari eruzioni del Vesuvio; era la spiaggia per eccellenza, il prolungamento dell’area portuale verso nord-est, il cordone ombelicale che da sempre ha unito il napoletano al mare.
Quella che oggi è Via Chiaia in origine fu un alveo torrentizio che convogliava verso il mare le acque discendenti dalle circostanti colline; in epoca romana, l’alveo fu prosciugato ed entrò a far parte della strada di collegamento con Pozzuoli. Il borgo circostante rimase fuori le mura fino al 1563 quando, con lo spostamento della Porta di Chiaja e l’inaugurazione della Villa Comunale, la zona iniziò a mutare aspetto. Nel 1884, con l’esplosione del colera e con la conseguente “Legge per il risanamento della città di Napoli“, quel tratto di paesaggio mutò completamente in nome della speculazione edilizia: le banche piemontesi finanziarono le operazioni di bonifica in cambio della possibilità di edificare nelle aree risanata, ma non del tutto: la facciata a mare fu bonificata, mentre i vecchi rioni interni del centro storico, esclusi dal risanamento, non ne ricavarono alcun beneficio.
La colmata del lungomare di Santa Lucia compresa tra il Castel dell’Ovo e la Villa Comunale (ex Reale) fu definita “palazzata borbonica” e – oltre agli edifici privati residenziali del Chiatamone – accolse gli alberghi più eleganti con vista-mare del panoramico Chiatamone (dal greco πλαταμον, platamón, che indica un’area piatta (spiaggia) di origine marina); addirittura al Comune di Napoli fu proposto un vero e proprio delitto: l’abbattimento del Castel dell’Ovo, un “rudere brutto e ormai inutile”, per fortuna mai approvato.
Invece, l’esecuzione delle opere di abbattimento concordate fu finanziata ed eseguita ad opera dell’imprenditore privato belga Ermanno Du Mesnil che in cambio ottenne il permesso di edificare il tratto prospiciente l’ex plaja, cioè il Viale Regina Elena, oggi viale Gramsci, che costeggia il lato interno della Villa Comunale di Napoli.
Nacque, così, a cavallo dei due secoli (‘800 e ‘900), l’ampia via che evocava i boulevards parigini e i loro “contre-allées“, cioè le piccole carreggiate laterali adibite a galoppatoio (i cosiddetti “trottoir” per i cavalieri, oggi riservati al traffico locale).
Tutto questo bendidio fu destinato alle “seconde residenze a mare” delle famiglie nobili napoletane, di cui rimangono gli stemmi nobiliari dei portoni; inoltre, quasi tutti i palazzi hanno un doppio ingresso: uno su viale Gramsci e uno su via Caracciolo.
Su moltissime iscrizioni della città troviamo ancora il nome Chiaja al posto del più attuale “Chiaia”.
L’isola del “mistero”
Nella riviera di Chiaia, poche decine di metri al largo della linea di costa (dove oggi si estende la Rotonda Diaz) esisteva un piccolo isolotto, che secondo una leggenda accolse una chiesetta detta di <San Leonardo a Chiaia>: disabitato, costituiva un approdo per piccole barche di pescatori e accolse, con la sua chiesetta dedicata al culto di San Leonardo, una piccola comunità religiosa, patrono dei carcerati, degli agricoltori, del bestiame, dei fabbri e delle partorienti.
La leggenda, mista a fonti storicamente acclarate, narra che un ricco mercante castigliano Leonardo d’Orio (o d’Oria) nel 1028 durante il viaggio con le proprie merci, scampò a una violenta tempesta e fece voto a San Leonardo (protettore delle partorienti, dei carcerati e anche dei naufraghi) che – in caso di salvezza – gli avrebbe edificato un centro di culto, nel luogo di approdo.
La sua imbarcazione trasportava un tesoro di merce preziosa che – recuperata solo in parte – costituì la base per l’edificazione della chiesetta, prima affidata ai monaci basiliani e poi alle suore domenicane dei Santi Pietro e Sebastiano: intorno alla chiesa (accessibile dalla spiaggia grazie ad un pontile in legno) sorse un borgo di pescatori che detenevano il diritto di pesca.
Il borgo costituì a lungo un’attrattiva turistica e accolse la celebre «Taverna di Florio» rinomata per la sua cucina marinaresca.
Nel 1648 il borgo cominciò a decadere; un gruppo di popolani napoletani, in una battaglia contro gli spagnoli, vi si asserragliarono impadronendosi dell’isola e, dopo sette secoli dalla fondazione del borgo, le case ormai fatiscenti, furono occupate da gente di malaffare, contrabbandieri e soldati, trasformando l’Isolotto monastico in un centro di contrabbando e criminalità.
Fonti
Pagina Facebook Etimologia delle parole napoletane
Riferimenti bibliografici: “Mare nostrum” di RAI Storia; Altevista. Org; G. Attina, M.R.Pessolano, F. Mangone, A. Forgione,palazzi di napoli.it; Wikipedia et Al, modificati;
Immagini -Wikimedia-: la spianata della plaja e la riviera di Chiaja del Van Vittel
Immagini -Wikimedia-: la spianata della plaja e la riviera di Chiaja del Van Vittel