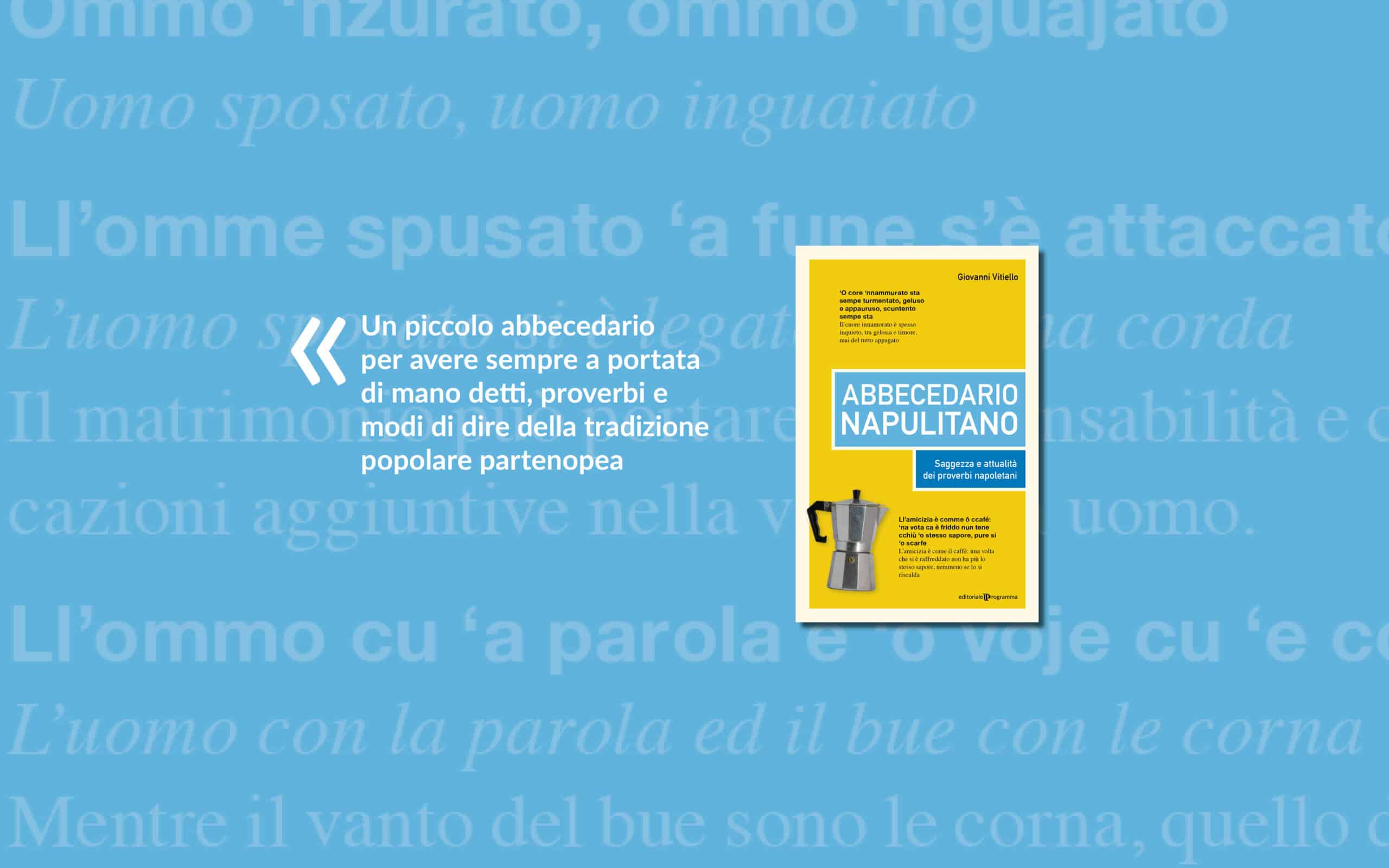‘O magliaro è un venditore di tessuti di bassa qualità che vengono proposti come affari da non perdere; in realtà si tratta di roba rubata o vecchia e recuperata, venduta a prezzi in apparenza convenienti: a conti fatti, però, quasi sempre si rivela un bidone.
I primi magliari napoletani attinsero merci nel Sud America e poi, dal secondo dopoguerra, dall’Europa industriale e/o mineraria, dove si erano indirizzati i flussi migratori degli operai italiani; il nome deriva dal fatto che la prima merce postbellica venduta furono gli indumenti di maglia detti per il colore, che era quello degli indumenti militari: i capi, venduti come se fossero di lana, appena messi in acqua, rivelavano la loro vera natura dozzinale e sintetica.
Nonostante tutto, però, il numero dei magliari crebbe subito e notevolmente e furono considerati dagli acquirenti veri e propri “imprenditori internazionali”, conquistandosi, già nell’Italia misera all’indomani della seconda guerra mondiale, una propria – grande – fetta di mercato e una precisa identità: erano quelli che recuperavano abilmente i dell’usato che arrivavano già nei primi anni del ‘900 da oltreoceano e forse da questo deriva l’espressione (cioè fregarlo); su questo torneremo in un prossimo post, ma è importante ora ricordare che il numero dei magliari crebbe in quel periodo notevolmente, provocando una reazione: ai magliari furono bloccati i passaporti, ma i più furbi subito richiesero una nuova concessione, non più come acquirenti di merce e tessuti usati, ma di cioccolato; mentre agli acquirenti proponevano tessuti in pezza o confezionati come o come prodotti acquistati a rate e recuperati in caso di insolvenza dell’acquirente.
Così i magliari post-bellici cambiarono il loro aspetto: smisero il loro sacco e l’abbigliamento misero e acquistarono credibilità grazie a una grande cura del loro aspetto e del loro abbigliamento e anche ad un eloquio dialettico molto preciso e finalizzato all’inganno. In un suo lavoro, Marco Godino racconta di Salvatore, un magliaro che alla stazione, al porto, smerciava un capo difettato tra le cui pieghe o tasche infilava un oggetto (orologio, penna, portafoglio) fintamente prezioso; faceva in modo che nascostamente il potenziale acquirente lo scovasse, poi contrattava l’acquisto del solo capo: scattava così la truffa e l’acquirente si illudeva di aver fatto un doppio affare!
Vittorio Paliotti, invece, racconta di Mario Gagliardi, che a Francoforte riceveva piazzisti alle prime armi, si appropriava della loro merce a basso costo e riusciva a rivenderla concludendo affari per milioni di marchi; questo enigmatico personaggio, ha poi ispirato il film di Francesco Rosi nel 1959, con protagonista un grande Alberto Sordi.
Curiosità
Nel periodo d’oro del loro mercato, i magliari giravano per i vicoli del centro storico alla voce: e in tanti si precipitavano a visionare la merce da acquistare; il loro arrivo diventava così “un’occasione di vita”, un vero e proprio evento collettivo.
Il mestiere è declinato con il consumismo e le grandi reti di vendita: la mondializzazione, con i suoi centri commerciali e la pubblicità ha ripreso in grande le idee-base del commercio dei magliari; la merce è offerta come occasione unica e imperdibile, ma le tecniche sono raffinate e il venditore è ritenuto più autorevole.
Fonti
Pagina Facebook Etimologia delle parole napoletane
Da alcuni miei vecchi post; M. Godino in ; A. Palumbo; M. Anselmo e P. Marcello in Wikipedia et Al. modificati, Immagini wikimedia