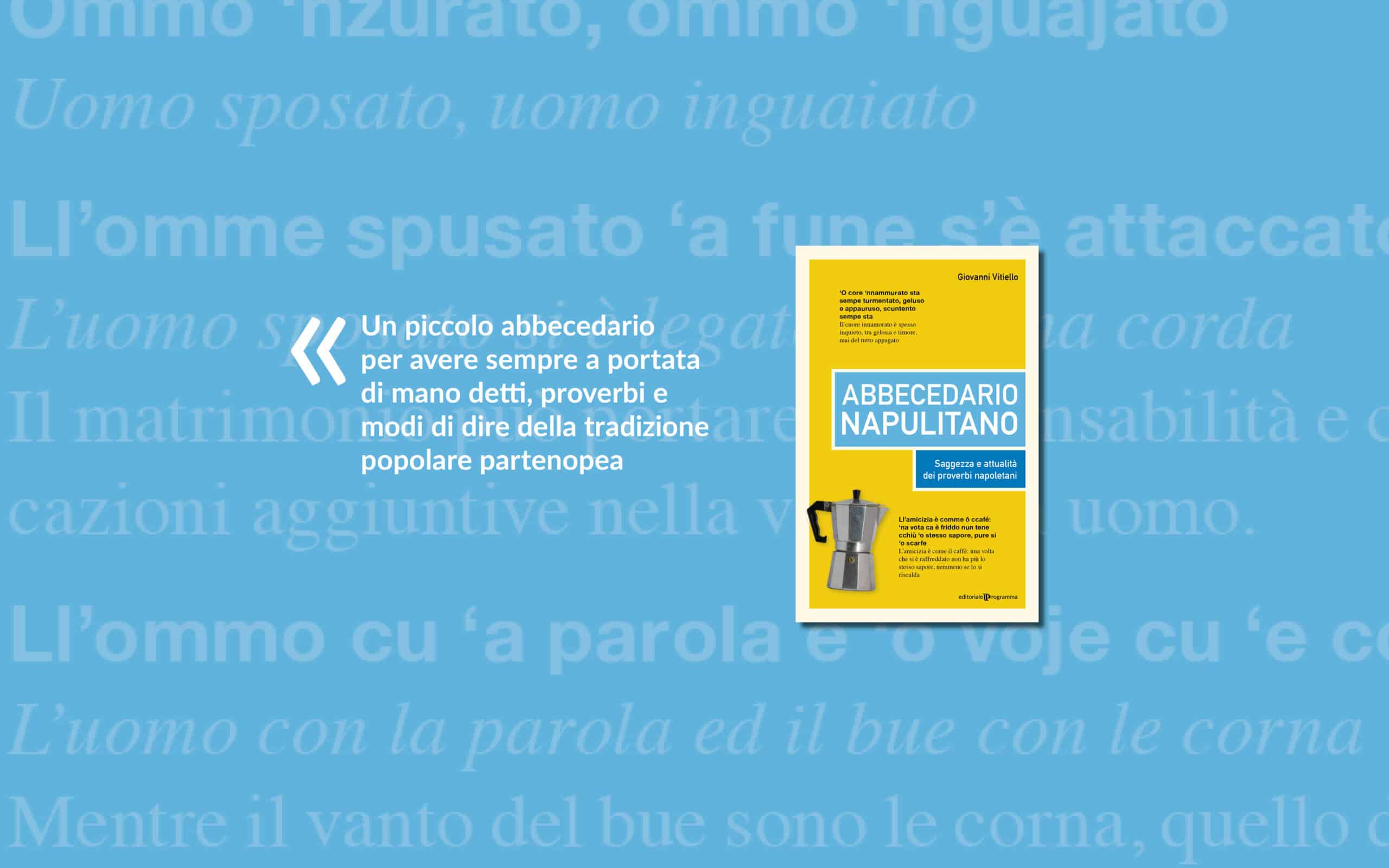*L’espressione “faccia di bronzo” indica una faccia tanto dura e inespressiva da non reagire in nessun modo agli stimoli, dome -ad esempio- le offese e/o i commenti sprezzanti.
* I Napoletani chiamano “Cavalli di bronzo” le monumentali sculture equestri che sovrastano la cancellata dei giardini di Palazzo Reale nell’area prospiciente Castel Nuovo. In realtà, la loro vera denominazione dovrebbe essere “Cavalli russi” perché furono donati alla città nel 1846 dallo Zar Nicola I.
L’imperatore russo aveva condotto la consorte Aleksandra Fёdorovna in Sicilia, sperando che il suo stato di salute migliorasse grazie al clima mite dell’isola; quando la cosa avvenne, la famiglia imperiale russa prolungò il suo viaggio con la visita di Napoli, capitale del Regno delle Due Sicilie. I sovrani russi furono accolti ed ospitati da Ferdinando II e dalla consorte Maria Teresa d’Austria a Palazzo Reale; poi, al ritorno a San Pietroburgo, lo zar inviò come regalo di ringraziamento ai sovrani napoletani due palafrenieri di bronzo colti nell’atto di domare i cavalli; le statue furono poste inizialmente sul cancello d’ingresso dei giardini reali in Via San Carlo poi alla fine dell’Ottocento furono spostate nell’attuale posizione. Opera del russo Pjotr Klodt Von Jurgensburg, furono creati insieme ad altri quattro gruppi equestri in bronzo, visibili ancora oggi a San Pietroburgo, al Ponte Anickov sul fiume Neva; due di essi (restaurati in tempi recenti e più volte spostati) sono del tutto identici a quelli donati a Napoli, perché Nicola intendeva gemellare Napoli e San Pietroburgo con allegorico ponte. In quegli anni Ferdinando II aveva avviato una serie di riforme urbanistiche di Napoli, Capitale del Regno delle Due Sicilie, per accrescerne decoro e prestigio. Tra le opere, c’era l’abbellimento del Palazzo Reale e la sua chiusura con una cancellata in ferro a lance con punte dorate, che fu ornata proprio dal dono dello Zar. La visita di Nicola intensificò i rapporti politico–commerciali tra lo stato russo e quello napoletano: a Kronstadt, una località isolana di fronte la Capitale russa, fu aperta una fabbrica uguale a quella di Pietrarsa; a San Pietroburgo arrivarono le repliche delle opere di maggio successo del Teatro San Carlo; mentre a Napoli si diffuse l’utilizzo del baccalà del Baltico, in Russia arrivarono la pasta e la pastiera. Si intensificarono gli scambi artistico-culturali di architetti, scultori, pittori, compositori, letterati; il napoletano Carlo Domenico Rossi, fu naturalizzato russo, la pittrice russa Irina Federava riconobbe pubblicamente che Napoli aveva rappresentato per i Russi la culla dei migliori talenti russi: pittori, scrittori, compositori, critici letterari. identici.
L’imperatore russo aveva condotto la consorte Aleksandra Fёdorovna in Sicilia, sperando che il suo stato di salute migliorasse grazie al clima mite dell’isola; quando la cosa avvenne, la famiglia imperiale russa prolungò il suo viaggio con la visita di Napoli, capitale del Regno delle Due Sicilie. I sovrani russi furono accolti ed ospitati da Ferdinando II e dalla consorte Maria Teresa d’Austria a Palazzo Reale; poi, al ritorno a San Pietroburgo, lo zar inviò come regalo di ringraziamento ai sovrani napoletani due palafrenieri di bronzo colti nell’atto di domare i cavalli; le statue furono poste inizialmente sul cancello d’ingresso dei giardini reali in Via San Carlo poi alla fine dell’Ottocento furono spostate nell’attuale posizione. Opera del russo Pjotr Klodt Von Jurgensburg, furono creati insieme ad altri quattro gruppi equestri in bronzo, visibili ancora oggi a San Pietroburgo, al Ponte Anickov sul fiume Neva; due di essi (restaurati in tempi recenti e più volte spostati) sono del tutto identici a quelli donati a Napoli, perché Nicola intendeva gemellare Napoli e San Pietroburgo con allegorico ponte. In quegli anni Ferdinando II aveva avviato una serie di riforme urbanistiche di Napoli, Capitale del Regno delle Due Sicilie, per accrescerne decoro e prestigio. Tra le opere, c’era l’abbellimento del Palazzo Reale e la sua chiusura con una cancellata in ferro a lance con punte dorate, che fu ornata proprio dal dono dello Zar. La visita di Nicola intensificò i rapporti politico–commerciali tra lo stato russo e quello napoletano: a Kronstadt, una località isolana di fronte la Capitale russa, fu aperta una fabbrica uguale a quella di Pietrarsa; a San Pietroburgo arrivarono le repliche delle opere di maggio successo del Teatro San Carlo; mentre a Napoli si diffuse l’utilizzo del baccalà del Baltico, in Russia arrivarono la pasta e la pastiera. Si intensificarono gli scambi artistico-culturali di architetti, scultori, pittori, compositori, letterati; il napoletano Carlo Domenico Rossi, fu naturalizzato russo, la pittrice russa Irina Federava riconobbe pubblicamente che Napoli aveva rappresentato per i Russi la culla dei migliori talenti russi: pittori, scrittori, compositori, critici letterari. identici.
*Nel 1870 a Napoli. in alcuni locali concessi dall’amministrazione comunale all’interno del Real Albergo dei Poveri, era stata impiantata da Gennaro Chiurazzi, già allievo all’Istituto di Belle Arti del maestro di scultura Pietro Masulli, una fonderia napoletana, specializzata nella riproduzione a grandezza naturale di statue di bronzo classiche e rinascimentali, ottenute con la tecnica “a cera persa” della fusione del metallo “a cera persa”. Da poco era stato aperto il Museo Archeologico di Napoli che collezionava i reperti provenienti dagli scavi di Pompei ed Ercolano e la richiesta di copie creava un ampio mercato + Chiaruzzi riuscì a sfruttare la possibilità di applicare le tecniche di riproduzione in serie offerte dalle innovazioni industriali senza però compromettere la qualità della lavorazione artistica. In breve tempo la fonderia Chiurazzi si dotò di una gipsoteca comprendente circa millecinquecento calchi in gesso di sculture provenienti non solo dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ma anche dai Musei Vaticani, dai Musei Capitolini, dal Museo Borghese di Roma, da Palazzo Pitti, dalla Galleria degli Uffizi e dal Museo archeologico nazionale di Firenze. L’attività della fonderia venne riconosciuta a livello internazionale con il conferimento di diversi premi, fra cui la medaglia d’oro alle esposizioni di New Orleans e di Torino del 1884 e il riconoscimento speciale all’esposizione di Saint Louis del 1904. Nel 1891 la fonderia allestì un’esposizione permanente delle proprie opere in piazza dei Martiri a Napoli e nel 1894 una seconda all’interno della galleria Principe di Napoli. Alla morte di Gennaro, la fonderia proseguì le attività grazie ai figli Federico e Salvatore, che cercarono di ampliare l’offerta dedicandosi anche alla produzione di marmi e ceramiche. Nel 1919 gli stabilimenti furono trasferiti ai Ponti Rossi. Nel primo dopoguerra, la fonderia fabbrica le sculture bronzee per i sacrari commemorativi dei caduti nella Grande Guerra. Nel 1925 fu aperta una seconda fonderia a Roma, in via Baldissera, per seguire in loco le commissioni provenienti dalla capitale, dove fu allestita in via del Babuino anche una sala per l’esposizione e la vendita. Fra il 1974 e il 1975, la fonderia fu impegnata a riprodurre tutti i bronzi rinvenuti nella Villa dei Papiri a Ercolano per conto del magnate del petrolio Jean Paul Getty, intenzionato a decorare con i bronzi Chiurazzi la villa-museo di Malibù. Il marchio nel 2011, dopo anni di inattività, è stato rilevato da una società dell’Arizona, che ne ha salvato il patrimonio artistico. Tra le opere internazionali della fonderia, ricordiamo: la Fontana del Tritone in Piazza Cavour a Napoli; la Quadriga dell’unità (artista Carlo Fontana) per il Vittoriano a Roma; le opere per il Campidoglio dell’Avana a Cuba.
Fonti
Da molti miei vecchi post, modificati e dalle molte notizie raccontatemi da Angelo Bonelli, che ringrazio; Immagini: i cavalli di bronzo.