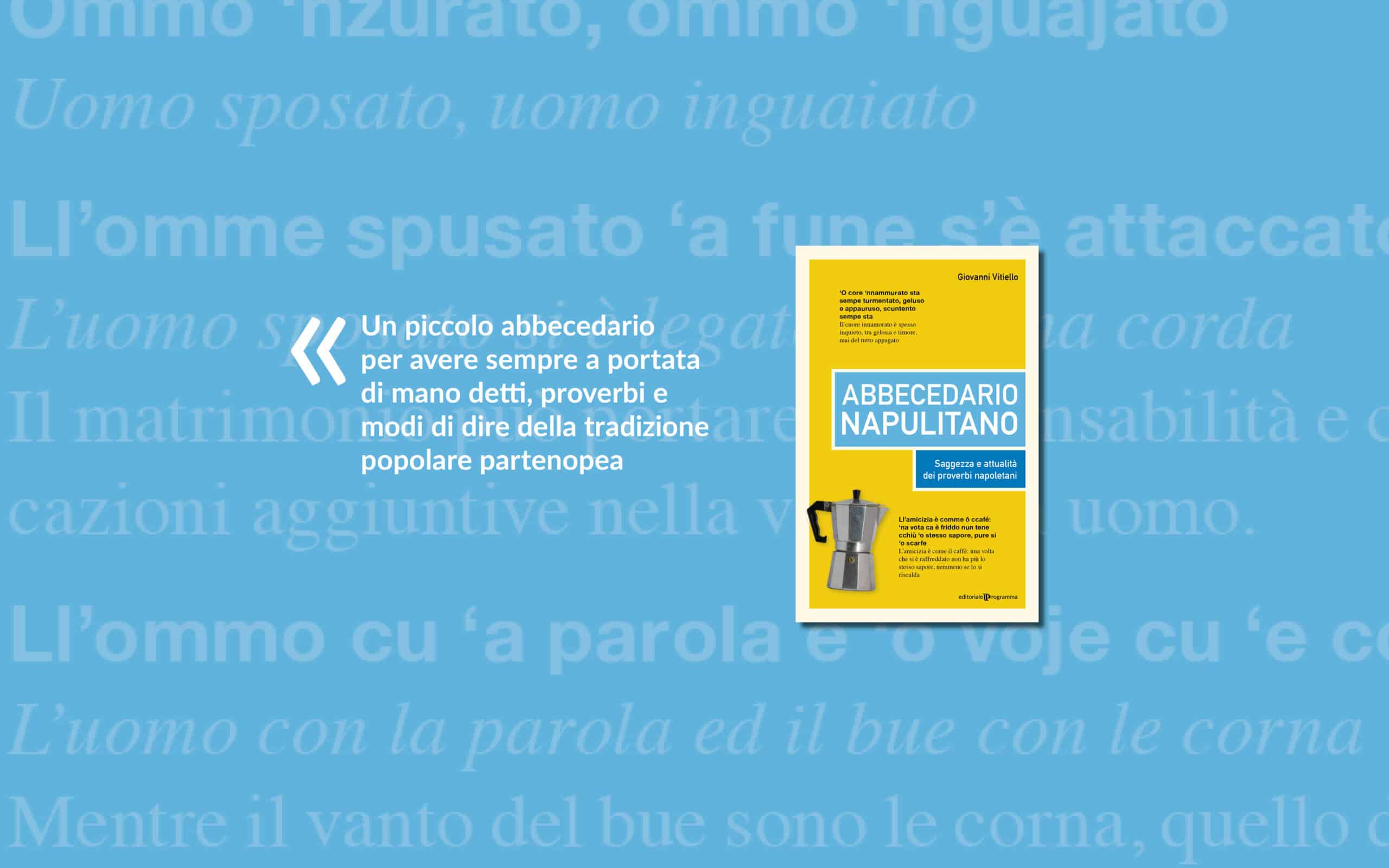Premessa
I giochi cartacei italico-napoletani più antichi sono lo scopone (scientifico, derivato dalla più semplice “scopa”) e il tressette; risalgono probabilmente al ‘500 ed erano praticati non solo dal popolino, ma anche dalle classi sociali più elevate, alle quali si rivolse Chitarrella, scrivendo una sorta di codice costituito da 44 regole per giocare e vincere in tutti i giochi di carte; il popolo, generalmente analfabeta, lo apprese “di seconda mano”, ma ne fece buon uso diffondendolo a sua volta in modo esteso.
Le regole principali si accentrano sul gioco dei 7 e sullo spariglio, cioè, la presa con una carta superiore di due o più carte inferiori, in modo da lasciare in gioco un numero dispari di quelle carte: in questo modo si evitano le “scope”, cioè le prese di tutte le carte rimaste sul tappeto da gioco. Il Codice di Chitarrella fu scritto in latinetto, è il latino approssimativo parlato dal popolo incolto.
* La prima regola definisce lo scopone, cioè la presa finale di tutte le carte rimaste sul tavolo, come se si scopasse. La seconda definisce i 4 “semi”: spade, coppe, denari, bastoni; ogni seme ha dieci carte: la carta di maggior valore è il sette e il massimo valore fra i sette lo ha quello di danaro, detto “d’oro” o “sette bello”. Seguono altre 38, minuziose, regole che stabiliscono le modalità di gioco e i punteggi da assegnare a ciascuna “giocata”. Lo Scopone -detto “scientifico”- è un gioco molto rigoroso, nel quale il “cartaro”(colui che dà le carte per primo) e il suo compagno cercano di mantenere pari le carte dello stesso valore; al contrario, gli avversari di spaiarle. La filosofia dello Scopone consiste nel guardare lontano e considerare, di là dal guadagno immediato, l’esito finale, esattamente come si fa negli affari.
Modi di dire
Il gioco ha generato molti modi di dire:
§ “Essere canusciuto comm’ ‘a sette ‘e denare”), ossia essere noto a tutti;
§ “Metterse a quatto ‘e bastone”, cioè, in posizione comoda, steso a pancia all’aria con gli arti allargati;
§ “Tenè ‘o fisico ‘e ll’asse ‘e spada”, rivolto alle persone esili e ricurve in avanti;
§ “Parè ‘n’asso ‘e bastone” cioè un uomo basso e brutto, ma con velleità di conquistatore;
§ “Fà mmiria ô tre bastone”, rivolto a donne che hanno peluria diffusa sul volto, soprattutto sopra la bocca;
§ “Tenè ‘e bbaffe” (come gli omini identificativi di alcune carte napoletane di grande valore).
Note
1. L’immagine del tre di bastoni immortalerebbe il guappo di quartiere Nicola Iossa, abile nel lancio di coltelli, che durante il periodo borbonico organizzava anche spedizioni punitivo-randellate. Secondo una delle tante leggende metropolitane, durante una sfida con il coltello ferì “Tore ‘e Criscienzo”, capocamorrista dell’epoca che per l’umiliazione subita si consegnò alla polizia come “prigioniero”).
2. I napoletani sono appassionati a tutti i giochi di carte, da quelli d’azzardo (stoppa, zecchinetto, sette e mmiezo) a quelli da tavolo (scopa, tressette e tutti i suoi derivati come “tre ‘a chiammà”, ecc.). Nonostante che i giochi delle carte abbiano speso rovinato economicamente il giocatore accanito e la sua famiglia, molti detti napoletani li esaltano e/o li riguardano:
§ “‘E carte so’ ‘e pezza e fanno chiagnere l’uommene senza mazza” (le carte -pezzi stracciati- fanno piangere solo gli uomini senza gli “attributi” idonei;
§ “Tirà a recchia” o nel “Trezzià ‘e carte; definiscono il piacere provocato dall’apertura lenta delle carte: perché scoprire a poco a poco le carte da gioco fa assaporare lentamente l’emozione: si scopre il margine superiore destro o sinistro delle carte da gioco lentamente, strofinandole l’una sull’altra e poi sfilandole una dopo l’altra tra l’indice e il pollice.
§ “Nun leggere maje ‘o libro ‘e quaranta foglie”, cioè il mazzo di 40 carte;
§“Chi nun sape perdere nun ha dda jucà’” cui si contrappone la giustificazione “L’ommo senza vizzie, è lo primo scartafazio (scartafazio, scartafaccio, col significato di superfluo, inutilizzabile)”, vale a dire che è come un libro non rilegato;
§ “‘A carta vène e ‘o jucatore s’a vanta” (è inutile vantarsi di un buon risultato ottenuto per caso)
§ “Tenè ‘o cinquantacinche mmano”), per traslato, “avere ottime possibilità di successo”
Fonti
Pagina Facebook Etimologia delle parole napoletane https://www.facebook.com/gabriellacundarietimologia
(dai miei vecchi post, Raffele Bracale e Giovanni Vitiello, modificati, immagine Wikipedia)
(dai miei vecchi post, Raffele Bracale e Giovanni Vitiello, modificati, immagine Wikipedia)