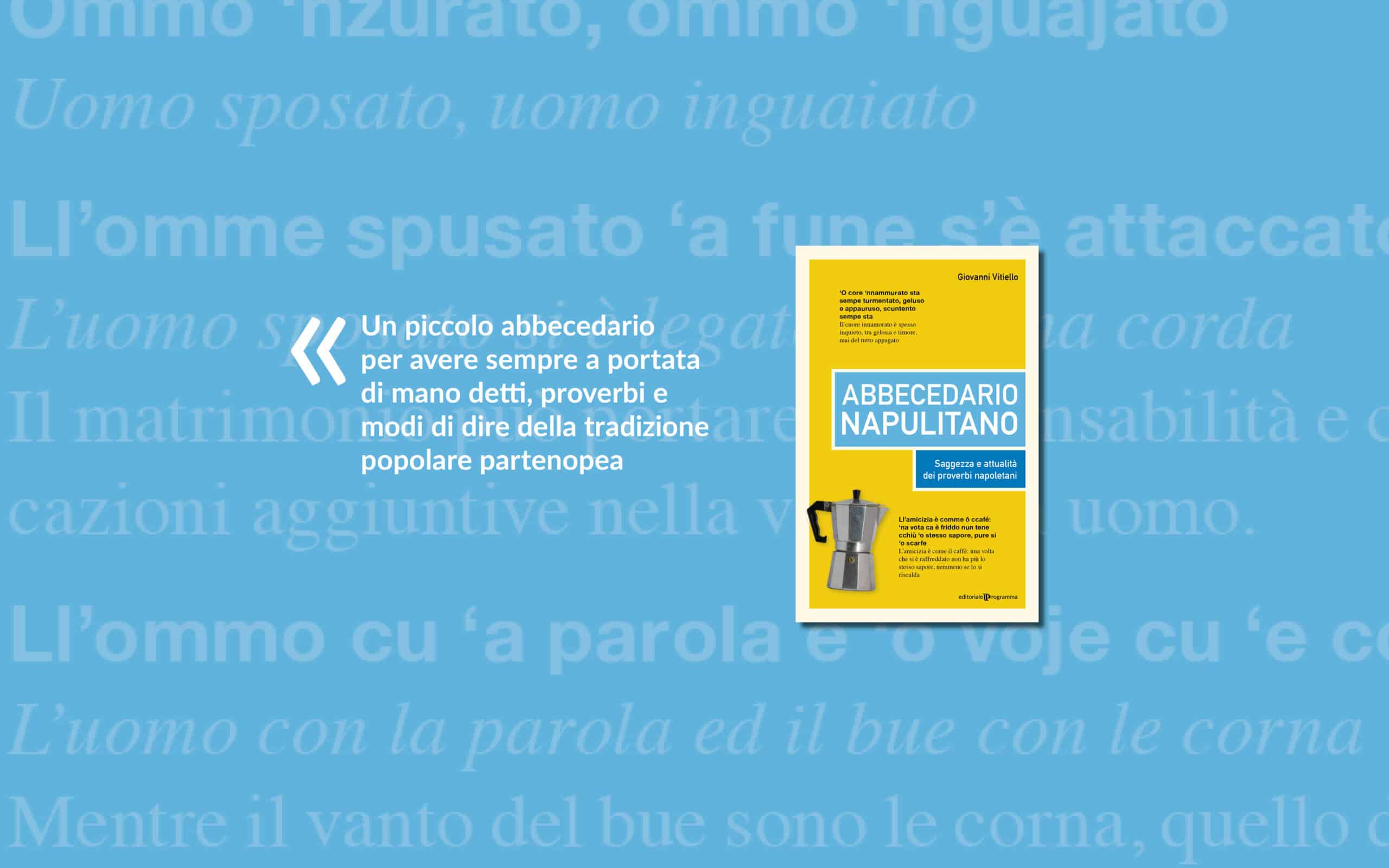In una Napoli che traduce in canto tutto ciò che accade, il repertorio musicale è amplissimo e occupa pagine e pagine di volumi importanti; gli spunti e le riflessioni che seguono sono solo un invito agli amici della pagina ad approcciarsi all’argomento.
Il post è dedicato ai periodi bellici che hanno colpito Napoli nel XX secolo, provocando eventi tragici, ma lasciando ai posteri un’eredità canora. Da sempre, infatti, la musica ha fatto parte non solo della vita dei soldati nei campi di battaglia o nelle retrovie, ma anche del popolo che ha dovuto affrontare lutti, privazioni; per questo, nel nostro contesto storico e sociale si collocano alcune delle canzoni napoletane più celebri e emblematiche, ispirate dai fatti bellici contingenti, “sentite” e “consolatorie” sul momento, poi destinate ad un successo che è andato ben oltre il periodo in cui furono composte.
I primi spunti napoletano musicale/bellico parte dalle imprese coloniali di fine Ottocento: delle canzoni, ormai dimenticate, mi limito a ricordare “Pe’ ll’ Afreca acurrimmo!“, del 1887: il testo e la musica erano di quel Berardo Cantalamessa reso poi famosissimo per la scherzosa “‘A risa” del 1895, che fu la prima registrazione fonografica assoluta in Italia; la canzone bellica, invece, racconta della colonizzazione dell’Africa Orientale da parte delle nostre truppe.
Ai tempi della Grande Guerra risalgono diverse canzoni, a partire da quella composta da Enrico Cannio nel 1915, con uno struggente testo da Aniello Califano, “’O surdato nnammurato”, il cui incipit indimenticabile è “Staje luntana da stu core, a te volo cu ‘o penziero …” e “Sentinella” (1917) di Ernesto De Curti e Roberto Bracco (“Tutte dormono ‘ncopp’ â sta cimma ‘e monte conquistato/ E i’ faccio ‘a sentinella e sto scetato”).
Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, Napoli nella lunga fase cruenta, in cui fu bersaglio dei bombardamenti degli aerei alleati, non cantò: obiettivo strategico e fronte di difesa principale (tanto da essere definita <porto dell’impero>); fu la città italiana più colpita da bombardamenti, con un numero di morti stimato tra le 20.000 e le 25.000 unità, costituita soprattutto da popolazione civile.
Coraggiosa e indomita, Napoli a si era già liberata da sola; ma quando il generale Mark Clark, comandante della Quinta Armata alleata, entrò nella città, i Napoletani lo accolsero lo stesso da vincitore e gli dedicarono una versione partenopea – intitolata “Ollero e Pistuddà”- della “Pistol Packin Mama“ di Al Dexter.
La “liberazione “ non era stata indolore: aveva comportato il mercato nero, il contrabbando di sigarette, la prostituzione; ma si cantò lo stesso: del 1944 ricordiamo “Dove sta Zazà” di Raffaele Cutolo, in arte Giuseppe Cioffi: ebbe un tale successo che Evita Peron la adottò come inno del suo partito mentre in città le giovani meretrici si chiamarono “’e signurine“.
Nel 1944, Edoardo Nicolardi e E.A. Mario composero “Tammurriata nera”, dedicato ai tanti bambini alla pelle scura concepiti durante la liberazione/occupazione americana (“ca tu ‘ o chiamme Ciccio ‘o ‘Ntuono /ca tu ‘o chiamme Peppe ‘o Giro / chillo, ‘o fatto, è niro niro, / niro niro, comm’ a cché..”).
E che dire de “Simmo ‘e Napule, paisà” la consolatoria di Giuseppe Fiorelli, e Nicola Valente: “Basta che ce sta ‘o sole / ca c’è rimasto ‘o mare /….chi ha avuto, ha avuto, ha avuto…/ chi ha dato, ha dato, ha dato…/ scurdammoce ‘o passato/ simmo ‘e Napule, paisà?”
Diverso, invece, è il tono della canzone del primo dopoguerra dedicata alla Chiesa di Santa Chiara e al suo monastero, distrutta proprio dagli aerei degli “Alleati” e non da quelli tedeschi. Protagonista del testo -insieme all’edifico sacro – è un emigrante smanioso di tornare a Napoli, timoroso di ritrovare la città distrutta dal conflitto mondiale. La canzone divenne una sorta di inno non solo napoletano, ma nazionale, perché rispecchiava i sentimenti di un popolo intero, non solo angosciato dalle distruzioni subite, ma anche dal problema di come affrontare un mondo completamente cambiato.
Epilogo etimologico tra il curioso e il divertente
La prostituzione, mestiere antico come il mondo (sappiamo con certezza che il primo bordello “ufficiale” fu istituito da Soleone nel IV secolo a.C.), ha come protagoniste femminili “‘e “zoccole”, da latino sōrex, scrofa oppure troia, mutuato in latino dal gaelico torc, femmina molto prolifica, che vive nelle sporche fogne ed ha frequentissime e “libere” abitudini sessuali.
Passata la guerra, “’E Signurine” (a Napoli anche “malafemmene” non sparirono affatto: il loro era da sempre un mestiere codificato ed esercitato per istrada, ma in ambienti chiusi detti già “lupanare” (da lupa, che nell’antica Roma equivaleva a prostituta), “bordelli” (dal francese bordel), “case di tolleranza”.
Le prostitute (dall’omonimo latino, con valore di “mettere in mostra”, “esporre”, “offrire a pagamento”) a Napoli sono chiamate anche “zoccole”: l’etimologia tradizionale è che derivi dal latino – già citat o- “sorcus”; ma una proposta fantasiosa e divertente la fa afferire all’abitudine antica delle prostitute dei Quartieri Spagnoli (zona centralissima molto frequentata) di indossare alti zoccoletti di legno che con il loro rumore attiravano l’attenzione dei potenziali clienti
Fonti
Pagina Facebook Etimologia delle parole napoletane
(da alcuni miei vecchi post ai quali rimando per una bibliografia più articolata, modificati, immagini: Wkipedia)