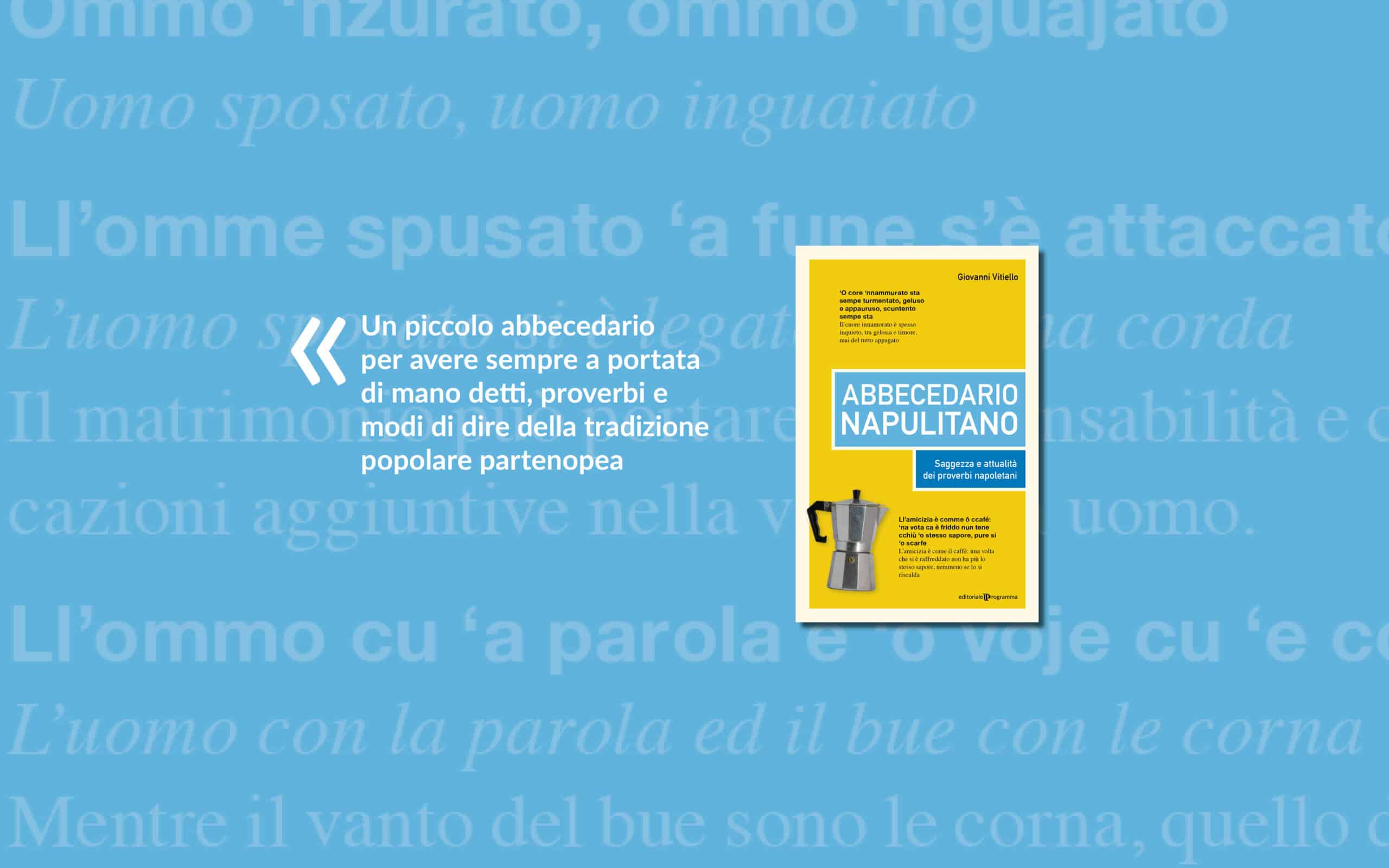Note storico / Aneddotiche
Il tre di bastoni nel mazzo di carte napoletano è rappresentato da tre mazze e una maschera di un uomo con grandi baffi a manubrio e sarebbe un riferimento al guappo di quartiere Nicola Iossa che, in pieno periodo borbonico, nelle sue imprese delittuose utilizzava oltre al lancio di coltelli, anche spedizioni punitive a randellate. Si racconta che fu nominato – proprio per la sua forza impropriamente considerata “coraggio”. responsabile di pubblica sicurezza e che durante una sfida con il coltello avrebbe ferito “Tore ‘e Criscienzo”, capo camorrista dell’epoca che per l’umiliazione subita si consegnò alla polizia come “prigioniero”.
I napoletani sono appassionati a tutti i giochi di carte, da quelli d’azzardo (stoppa, zecchinetto, sette e mmiezo) a quelli da tavolo (scopa, maniglia, tressette e suoi derivati: tre ‘a chiammà, chi perde, ecc.).
Il gioco delle carte con poste in danaro ha spesso ha rovinato famiglie. Ma i nostri detti (“‘E carte so’ ‘e pezza e fanno chiagnere l’uommene senza mazza” e “Tre cose cunzumano ogne luoco: fuoco, juoco e trattore”) sorvolano spesso sugli aspetti “dolorosi” e sottolineano invece Il godimento che si prova nel “Tirà a recchia” o nel “Trezzià ‘e carte).
Tuttavia, ci sono detti che consigliano di stare alla larga (“Nun leggere maje ‘o libro ‘e quaranta foglie“), soprattutto se non si è abituati a perdere (“Chi nun sape perdere nun ha dda jucà”), ma avendo in mente che L’ommo senza vizzie, è lo primo scartafazio (scartafazio, scartafaccio, col significato di superfluo, inutilizzabile).
Ma, alla fine, subentra la rassegnata bonomia partenopea: (“Carte e donne fanno chello ca vonno“) e che la fortuna è cieca: ‘A carta vène e ‘o jucatore s’a vanta (è inutile vantarsi di un buon risultato ottenuto per caso).
E quale miglior fortuna, nel gioco del sette e mezzo, avere il punto massimo (“Tenè ‘o cinquantacinche ‘mmano“), che per traslato ha il significato di avere ottime possibilità di successo?
Occorre ricordare che i giochi di carte sono detti “spassatiempo“, al pari delle ciociole – soprattutto natalizie – che accompagnavano i momenti ludici post-prandium.
Il termine ciociola/e (o sciosciole’, sciociole, scioscelle) deriva da ciocio ovvero ‘sciocco’, dal latino soccus, che ha generato anche “zoccolo/i”.
Fonti
Pagina Facebook “Etimologia delle parole napoletane” (https://www.facebook.com/gabriellacundarietimologia)
Da un mio vecchio post , modificato e dalle tante riflessioni di Raffaele Bracale
Immagine: ‘o tre ‘e bastone