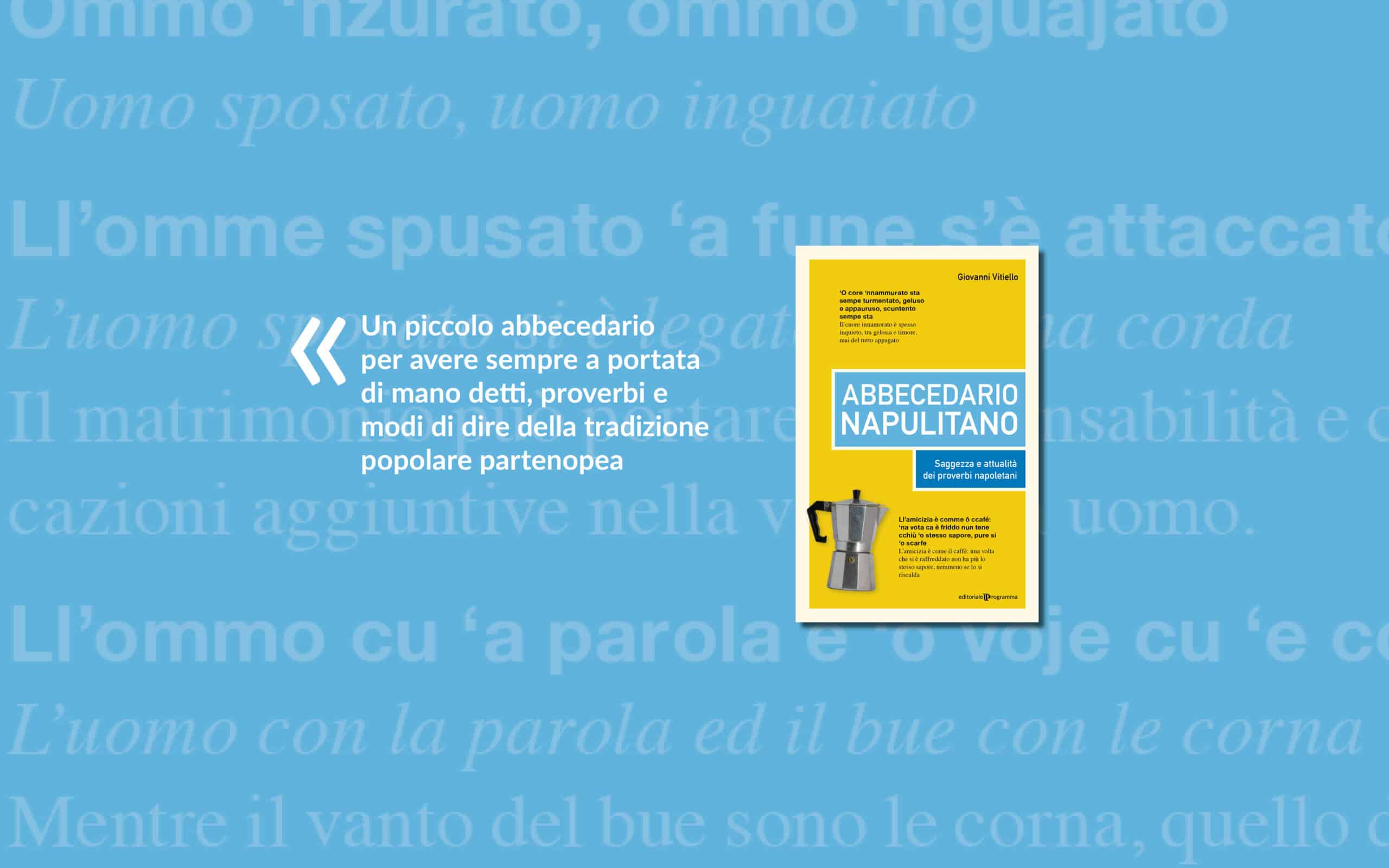Il ponte Real Ferdinando (detto anche Ferdinandeo) è un ponte sospeso sul fiume Garigliano situato nei pressi dell’area archeologica di Minturnae (Minturno), al confine tra Campania e Lazio. Fu il primo ponte sospeso a catenaria di ferro realizzato in Italia, e il secondo ponte del genere in Europa, dopo quello inglese (l’Union Bridge, di 137 metri, sul fiume Tweed, tra Scozia e Inghilterra, progettato dal capitano di marina Samuel Brown e anch’esso realizzato con catene).
Poco prima della costruzione napoletana, era fallito in Francia il tentativo di realizzare un ponte sospeso sulla Senna. Il Regno delle due Sicilie, dal punto di vista tecnico costruttivo era allora all’avanguardia in Europa: il geologo lucano Carminantonio Lippi aveva scritto ben cinque memorie sull’utilizzo del ferro e sulla validità della sospensione del ponte, formulando proposte avanzate e innovative, in un’epoca e in una Napoli scientifica refrattarie all’innovazione; l’ingegnere Luigi Giura, dopo numerosi viaggi condotti in Inghilterra e in Francia, presentò nel 1822 un suo progetto al sovrano che lo approvò e lo incaricò della realizzazione.
Largo 80,40 metri il ponte ha una lunghezza complessiva di 128 metri. Il sistema di sospensione è costituito da due coppie di catene di ferro prodotto nelle ferriere calabresi di Mongiana del generale Carlo Filangieri, principe di Satriano e duca di Cardinale e distanziate tra di loro 5,80 metri. I lavori furono iniziati nel 1828 e terminati il 30 aprile 1832: l’inaugurazione alla presenza del re avvenne dieci giorni dopo, il 10 maggio 1832. Definito “orgoglio del Regno”, ebbe vita lunga e sicura; ma 14 ottobre 1943, i tedeschi, dopo averci fatto transitare il 60% della propria armata in ritirata compresi carri e panzer, lo fecero saltare. La campata fu minata in due punti, eppure i piloni e le relative basi non subirono danni irreparabili. Nel 1988, con un progetto di archeologia industriale presentato dall’europarlamentare Franco Compasso, il restauro del ponte è stato finanziato dalla Comunità Europea, ma i lavori sono durati oltre 10 anni e la nuova inaugurazione è avvenuta solo a fine 2001.
Un gustoso aneddoto
L’ingegnere. Luigi Giura lavorava nel Corpo Ponti e Strade, antesignano del futuro Genio Civile, quando fu incaricato da Ferdinando II della costruzione del ponte. Giura iniziò un viaggio di studio per osservare, studiare e disegnare (non esisteva la fotografia), poi presentò un elaborato completo e dettagliato in tutte le sue parti compresi rilievi, sondaggi del terreno ed il costo totale (chiavi in mano); il re approvò e Il 20 maggio 1828 furono iniziati lavori.
Subito uscirono i detrattori – soprattutto inglesi – che espressero “perplessità sulle capacità progettuali e costruttive dei napoletani … vive preoccupazioni sulla sorte dei poveri sudditi, sicure vittime di un vano esperimento di sprovveduti …”, corroborate dal fatto che tutti i ponti sospesi in ferro già realizzati presentavano lo stesso problema: la grande oscillazione causata da grossi pesi e dal vento, quando era forte.
A Parigi, a causa del vento, era crollato il ponte sospeso in ferro progettato dall’accademico Navier; a Londra era stato chiuso il ponte Driburgh sul Twed e in tutta Europa si criticava quel tipo di costruzione. Quando l’eco di questi avvenimenti giunse a Napoli, il Consiglio dei ministri del Re era del parere di non dar luogo ai lavori. Il sovrano non si scompose e si narra ; non a caso ‘o guaglione (Luigi Giura) aveva trovato un ingegnoso sistema per rallentare la pressione del vento e, per aumentare la resistenza del ferro dolce, aveva fatto produrre dalle fonderie di Mongiana una lega al nichel “irrigidire” le travi di ferro: questo innovativo doppio trattamento, chimico e meccanico, conferiva al materiale una notevolissima resistenza alla corrosione ed all’invecchiamento.
Nonostante le perplessità di molti (ad es. gli Inglesi. che sul ipotizzarono per il ponte un sicuro crollo), il 10 maggio 1832 Ferdinando II si presentò davanti alle torri di sostegno del ponte alla testa di due squadroni di lancieri a cavallo e 16 carri pesanti di artiglieria, colmi di materiali e munizioni. e procedette all’attraversamento del ponte. Il vescovo di Gaeta, seguito dal popolo in processione, benedisse la cerimonia che si concluse con fuochi d’artificio, danze e canti in un tripudio di folla.
Il ponte costò al Regno circa di 75 000 ducati, equivalenti a circa 30 miliardi di lire, vale a dire poco più di 15 milioni di euro attuali. Il rifacimento del Ponte di Genova è costato circa 202 milioni di euro (cui vanno aggiunti i costi di demolizione della struttura precedente).
Collegamento fondamentale tra le vie peninsulari, è stato un grande protagonista della nostra storia: vi si svolse la battaglia del Garigliano (29 ottobre – 2 novembre 1860), prima dell’assedio di Gaeta; il 13 febbraio 1861 fu testimone muto della fine del Regno. Più tardi, la sua distruzione rientrò nel piano di difesa dell’esercito hitleriano per ostacolare l’avanzata delle truppe alleate da Sud, sfruttando la morfologia del territorio a proprio vantaggio. Così, dopo aver fatto transitare su di esso buona parte delle truppe e dei mezzi corazzati, i Tedeschi minarono la campata in più punti, distruggendola (ma c’è chi afferma che a distruggerlo siano stati gli Alleati). Fortunatamente le colonne “egittizzanti” e le relative basi non subirono danni irreparabili.
Il suo restauro risale al 1998 e oggi il ponte sul Garigliano è di nuovo al suo posto e visitabile.
Fonti
Da C. Lippi, R. Parisi, centrostudicamoani.com, portaledelsud.org, altervista.org,com, un mio vecchio post, et Al. modificati.