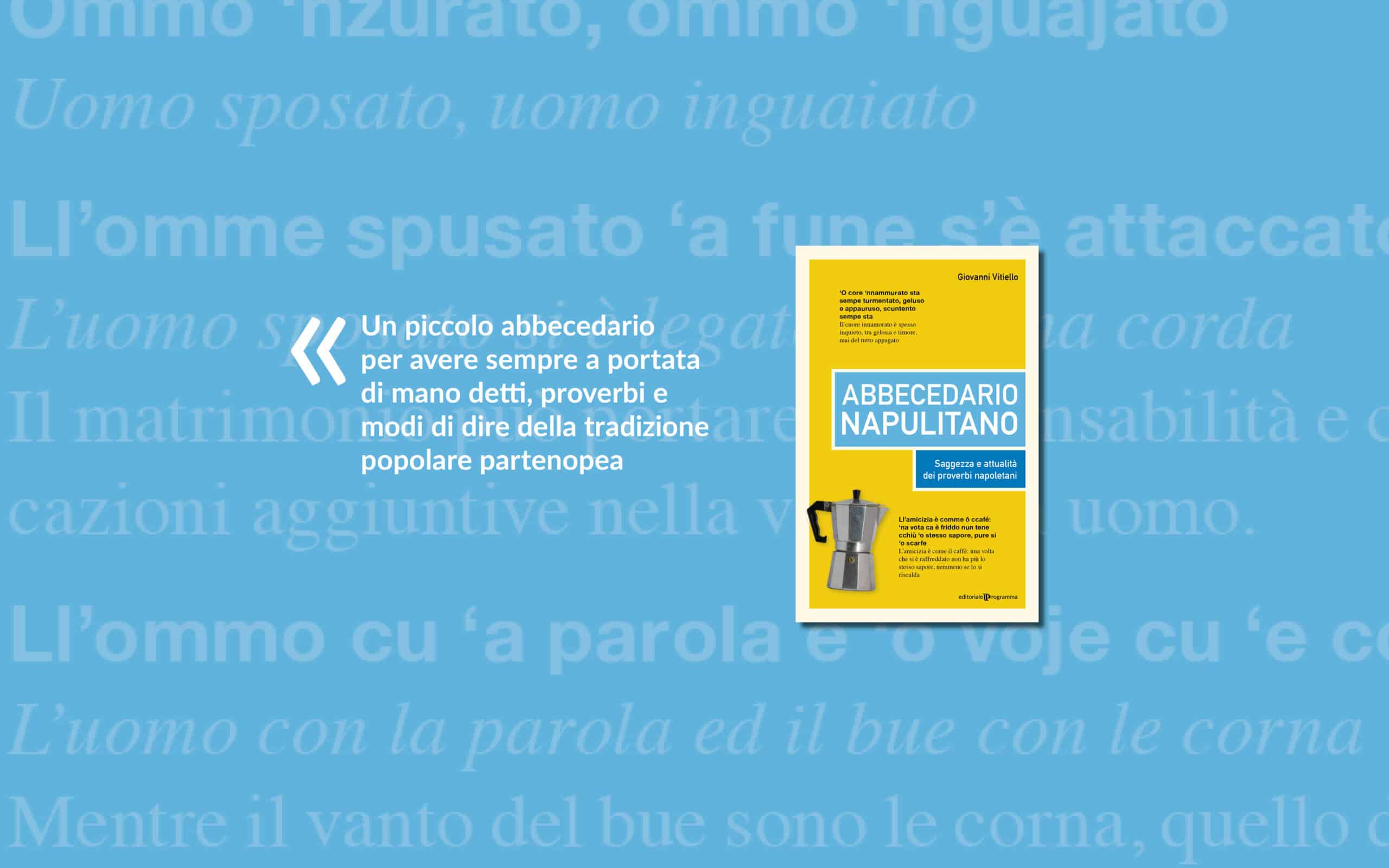Premessa
Chiapp’ ‘e ‘mpesa, allude scherzosamente al fatto che per frenare le mille capacità delle donne più smaliziate accorerebbe una …forca.
Come e quando nacque questa espressione? Chiappàre, come il suo rafforzativo acchiappare, è verbo trecentesco, originato dal latino “capulare”, “accalappiare”, “prendere col laccio? e in italiano indicava il nodo scorsoio utilizzato per l’impiccagione; invece a Napoli fu utilizzato genericamente per tutti gli strumenti ideati grazie all’abilità di escogitare risoluzioni di piccoli problemi pratico/meccanici.
Chiappo ‘e ‘mpiso, dunque, originariamente era di genere maschile e indicava un impiccato (“‘mpiso“, participio passato del verbo ‘mpennere da in + pendere = sospendere si univa a “chiappo“, cappio, dal latino capulum = fune e al femminile viene utilizzata nel significato di accalappiare con mille arti; da questa interpretazione nasce anche l’utilizzo del termine “chiappa” per indicare specificatamente le natiche femminili, che -opportunamente ondeggiate- hanno una forte capacità attrattiva.
La storia di una canzone e del suo autore
Mario Costa (tarantino di nascita con un avo (Carlo) importante compositore) si trasferì con la famiglia a Napoli nel 1865 e studiò musica e canto presso il conservatorio di San Pietro a Maiella.
Una volta diplomato, fu autore prolifico di romanze, canzoni popolari, melodie, stornelli, duetti, inni, marce, pantomime, opere comiche, operette, danze, fiabe; di questa enorme produzione, il brano più raffinato è “Era de maggio“; ma molto celebre fu “‘A frangesa” di cui compose versi e musica di sul tavolo della birreria “Strasburgo”, un locale ubicato in piazza Municipio (allora piazza Castello), dove si consumavano assaggi e birra, ascoltando musica concertistica: tra i clienti abituali c’erano, per esempio, Ferdinando Russo e Salvatore Di Giacomo.
La prima versione risale al 1894 di Armand’Ary cui fu dedicata.
La canzone, poi, fu portata al successo dalla cantante tarantina Anna Fougez che, nei Café Chantant dell’epoca, raccoglieva grandi consensi muovendo ad arte le natiche e intonando la frase “I’ so’ ‘na chiapp’ ‘e ‘mpesa, ve l’aggi’ ‘a dì!”.
Secondo alcuni, ‘A frangesa deve la sua popolarità al fatto che fosse particolarmente adatta per eseguire “’a mossa“, emblema delle effettive capacità di ogni sciantosa (le più ricordate oggi in Italia sono Gina Lollobrigida, Angela Luce Miranda Martino).
I cafè-chantant, nati in Francia alla fine dell’’800, costituirono il più diffuso intrattenimento leggero, alternativo al teatro, offrendo ai clienti piccoli spettacoli di canto, ballo, recitazione, giochi di prestigio.
A Napoli, è ricordato in particolare il Salone Margherita, inaugurato nel 1890, che ricalcava fedelmente il modello del Moulin Rouge e de Les Folies Bergere: compreso l’uso della lingua francese per i camerieri, tra gli ospiti, nei cartelloni, nella (millantata) provenienza Parigina delle artiste. Le artiste erano le “chanteuse”, letteralmente “cantanti”, che in Napoletano divenne “sciantosa”. E proprio “Songo frangesa e vengo da Parigge” rese Mario Costa.
Col passare del tempo, il termine “sciantosa” acquisì sempre più il significato di donna fatale, seducente, ammaliatrice; per aggiungere un alone di mistero intorno al proprio personaggio. le “dive” si prodigavano in atteggiamenti esotici e parlavano con accento straniero, diffondendo sul proprio conto passato immaginarie storie d’amore con esponenti famosi.
Una delle esponenti più misteriose fu Olimpia Arditi (in arte d’Avigny), la cui storia è particolarmente intrigante nella sua semplicità: nata a Napoli nel 1872, studiò nell’Istituto Suor Orsola e mostrò le sue embrionali capacità sceniche in una rappresentazione teatrale della sua classe.
Contro la volontà della famiglia, abbandonò gli studi da maestra ed iniziò la sua carriera artistica in una compagnia itinerante, con la quale divenne popolare in tutta Italia e anche a Parigi dove interpretò le sue canzono con il nome “Olympia la Napolitana”.
Dal 1899 fece coppia con Berardo Cantalamessa, importantissimo autore, che per primo in Italia registrò su disco una canzone, “‘A risata”. I due furono compagni anche nella vita; insieme fecero diverse tournée all’estero e in particolare furono scritturati dal Teatro Casino di Buenos Aires, dove ottengono un successo tale da convincere Cantalamessa a stabilirsi definitivamente nella capitale argentina; dal canto suo, Olimpia prese lezioni di danza brasiliana e tango argentino dalla ballerina Maria Cores; con lei ritornò in Italia e la coppia debuttò all'”Eldorado” di Napoli il 26 Agosto 1906; il successo fu grande e la coppia si esibì in tournè a Milano, Torino, Parigi, Nizza, Marsiglia, Lisbona e Madrid riscuotendo un successo senza precedenti.
Ma nel 1911 la coppia artistica si sciolse; Olimpia ricominciò da solista, con un repertorio misto di canzoni napoletane e “cuplè” spagnolo che ebbe grande successo.
Ma il richiamo dell’amore – solo in apparenza finito – la riportò dopo qualche anno a Napoli, dove si ricongiunsi a Berardo Cantalamessa fino alla morte per poi ritornare a Madrid, dove le sue condizioni economiche diventarono disastrose, tanto che per lei molti artisti – non solo madrileni – organizzarono serate di beneficenza al Chueca.
Ma la sua vita continua ad essere fonte di leggende, come quella del suo rifugio (?) in un convento in Italia e della sua favolosa collezione di gioielli – un capitale immenso – donata non al convento di cui una sua sorella è badessa, ma a quello di Santa Brigida di Napoli, di cui è gran devota.”
Fonti
Pagina Facebook Etimologia delle parole napoletane
Dalla biografia curata da Ettore De Mura in <Enciclopedia della canzone Napoletana>;
le riviste: “Musica e musicisti” e “Cafè Chantant”
Immagini Wikipedia
le riviste: “Musica e musicisti” e “Cafè Chantant”
Immagini Wikipedia