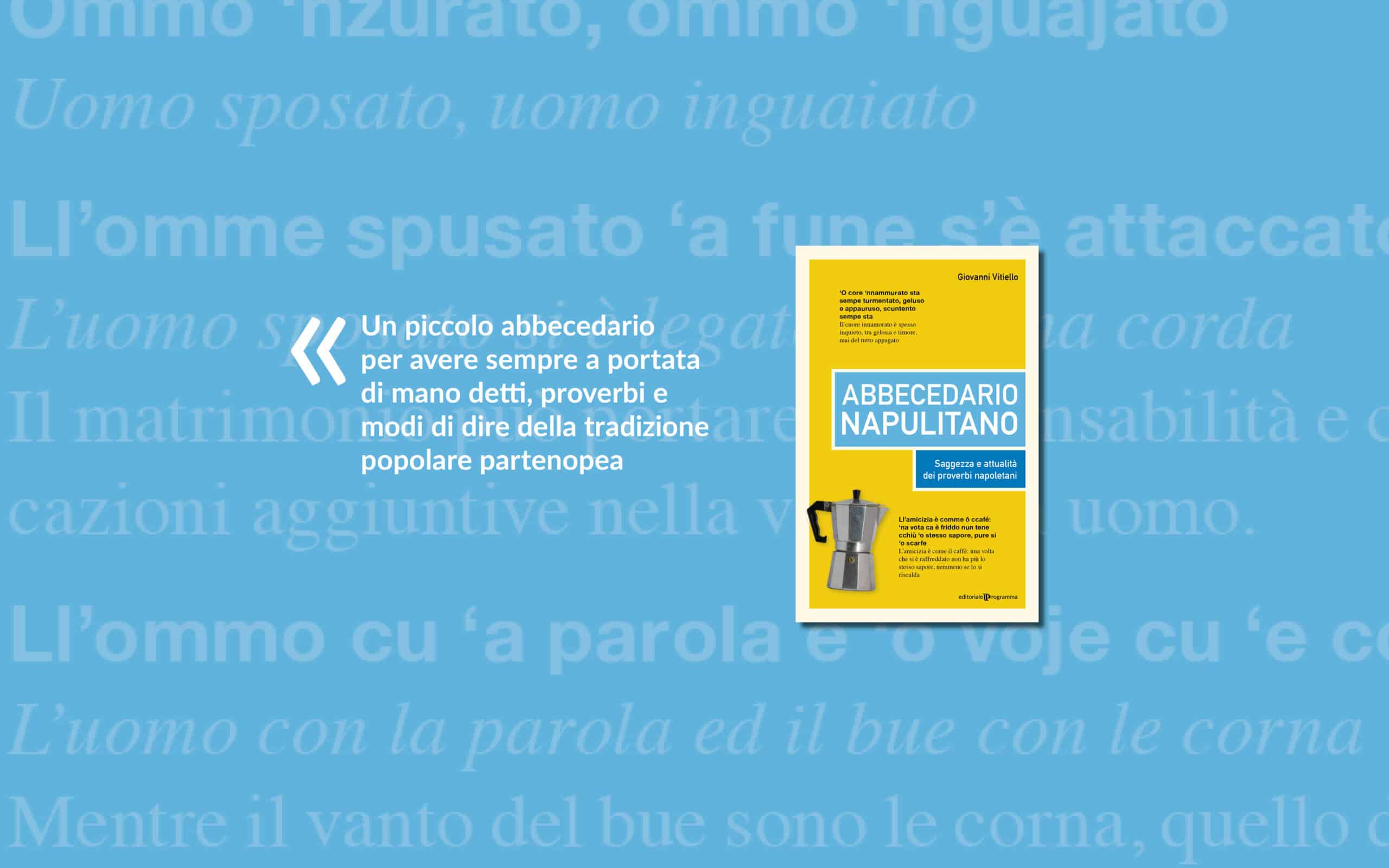Premessa: “Repetita juvant“, dicevano gli antichi romani
La quantità di affezionati della mia pagina è cresciuta a dismisura e molti -ma non tutti- sono abili ricercatori e ritrovano da soli i miei vecchi posts. Per quelli che non lo fanno, sto riprendendo il tema di quelli più lontani nel tempo; ma essendo sempre stata incapace di copiare (nemmeno i temi: la mia “brutta” e la “bella” erano simili, mai uguali), la versione del post che ripropongo sarà sempre leggermente diversa e aggiornata.
Chi nun tene denare va facenno zelle (diebbete), recita l’antico detto.
Se ne andavano cu ‘na mano annanze e ‘n ‘ata arreto i debitori che si allontanavano dal luogo dove avevano eseguito la cessio bonorum davanti al tribunale della Vicaria di Napoli, dimostrando con la nudità, di non aver più niente che potesse saldare le sue passività. E, non avendo nulla per risarcire i creditori, se ne jevano, con una mano davanti ed una di dietro (cioè, senza nulla), dal quartiere, della città dove avevano vissuto, con la speranza di ricominciare.
Ma, più frequentemente, finivano in galera dopo essere stati sottoposti a giudizio …
Ma, più frequentemente, finivano in galera dopo essere stati sottoposti a giudizio …
La Gran Corte della Vicarìa fu tribunale vicereale, istituito da Carlo II d’Angiò; nel 1492 per una epidemia di peste, da Napoli la Gran Corte della Vicaria venne trasferita a Frattamaggiore in un palazzo (che da allora in poi si denominò Palazzo del Vicario; ritornato nella sua sede ufficiale, vi ripresero le esecuzioni capitali nella parte settentrionale del cortile e le teste, nonché varie parti del corpo dei condannati, venivano esposte all’angolo del castello di fronte via Carbonara.
Davanti alla porta principale del Castello, invece, si svolgeva Il procedimento della “zitabbona”, dal latino “cedo bonis” che riprese l’uso dell’antica Roma dove i debitori erano esposti e puniti sulla “pietra dello scandalo”.
A Napoli, invece, il debitore insolvente saliva su una colonna bianca di marmo chiamata “culonna ‘nfame d’ â Vicaria” (colonna infame della Vicaria; il nome era analogo a quello Manzoni – docet -della colonna milanese destinato agli untori della peste).
A Napoli, invece, il debitore insolvente saliva su una colonna bianca di marmo chiamata “culonna ‘nfame d’ â Vicaria” (colonna infame della Vicaria; il nome era analogo a quello Manzoni – docet -della colonna milanese destinato agli untori della peste).
Dunque, calate le brache, l’insolvente doveva mostrare il deretano alla folla pronunciando il “Cedo bonis” (o “Cedo bona”, svendo tutti i miei beni, cioè nulla) dopo di che i creditori non potevano più rivalersi su di lui. Da questa macabra usanza si originano due locuzioni napoletane:
a) Mannaggia ’a culonna!, una maledizione rivolta alla colonna che stigmatizzava le condizioni debitorie; b) Ha mmustato ‘o cul’â culonna, che si dice di persona piena di debiti, anche oggi che la colonna alla Vicaria non c’è più.
a) Mannaggia ’a culonna!, una maledizione rivolta alla colonna che stigmatizzava le condizioni debitorie; b) Ha mmustato ‘o cul’â culonna, che si dice di persona piena di debiti, anche oggi che la colonna alla Vicaria non c’è più.
La Colonna non è sparita: è conservata nell’androne delle Carrozze della Certosa di San Martino ed è visibile nel celebre dipinto di ignoto del Seicento Il Tribunale della Vicaria esposto nello stesso Museo, come indica la freccia in rosso.
Nota … fisiologica
Il mostrare il deretano costituiva la condizione di sottomissione completa agli eventi e poteva durare a lungo, tanto che il debitore era giocoforza costretto a fare i suoi bisogni pubblicamente.
Per questo motivo, il deretano era spesso bagnato e da qui l’espressione Stà cu ‘e ppacche dinto a ll’acqua che significa essere squattrinato, al pari dei debitori della Colonna Infame.
Questa ipotesi è – però – controversa, perché molti studiosi (es. R. Bracale) l’attribuiscono allo stare in mare per pescare con la sciabica (Sciaveca in napoletano, dall’arabo shabaka), imbarcazione sulla quale i marinai dovevano calarsi in mare per le manovre più difficili; ma non si capisce -però- il nesso dell’operazione faticosa con il significato dell’espressione che è quello che in italiano corrisponde ad “essere sul lastrico” (da latino medievale astrăcum, dal greco. ὄστρακον, ostraco, cioè il coccio/ conchiglia con cui si rivestivano i terrazzi, incrociato con lastra) in senso figurato essere ridotti in miseria.
Tutto questo avveniva in uno scenario orripilante, fatto di condannati a morte impazziti, scugnizzi che urlavano, prigionieri in catene. Salire su questa colonna rappresentava una delle condanne più umilianti e infamanti che si potevano subire, per questo motivo venne soprannominata “a culonna ‘nfame della Vicaria”.
Fonti
Pagina Facebook Etimologia delle parole napoletane
Da un mio vecchio post, R.Bracale, S.Zazzera, V.Ceva Grimaldi et Al., modificati – immagini Wikimedia: la piazza della Vicaria nel dipinto seicentesco)