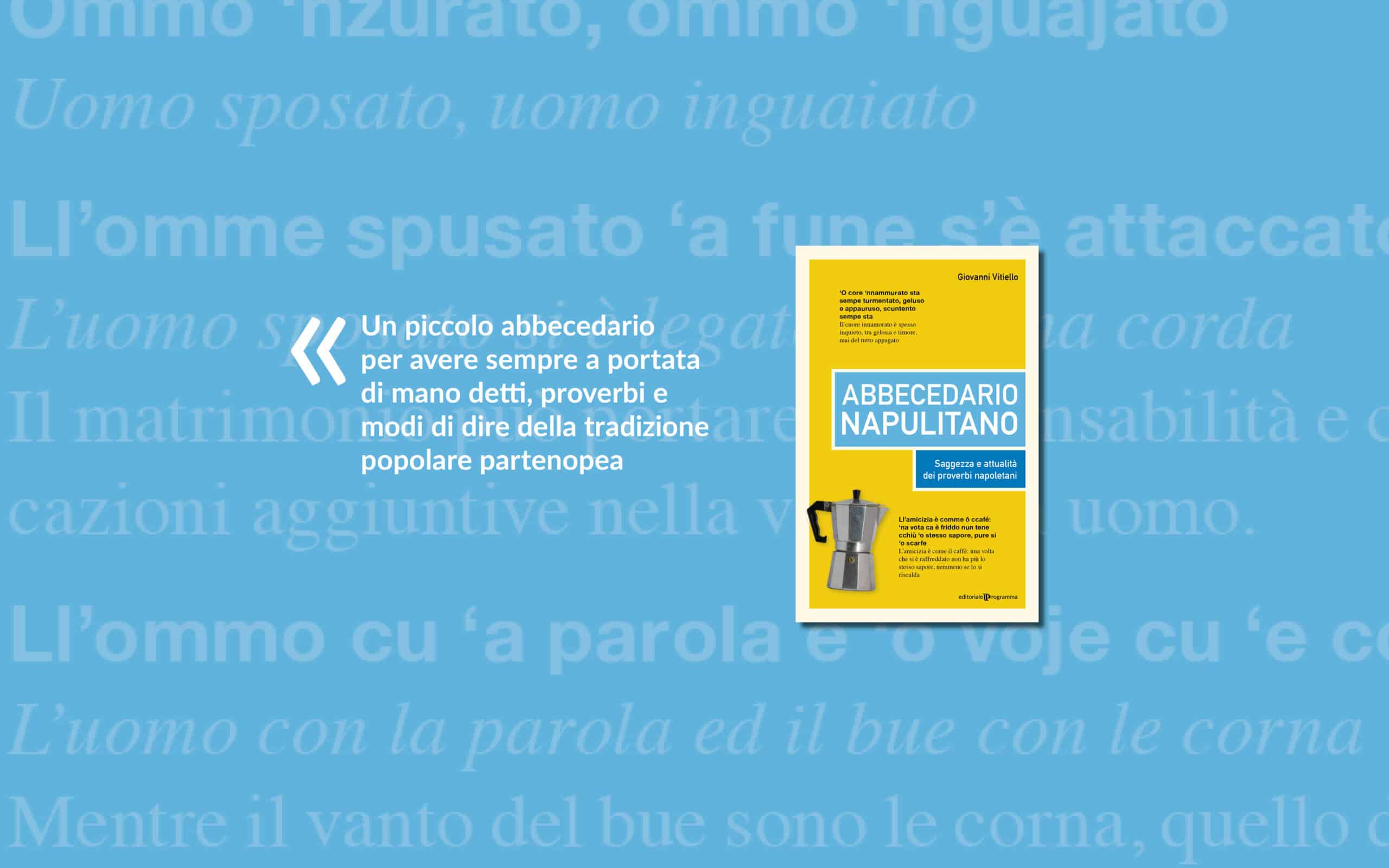Premessa
A molte donne piace il genere maschile “repassatore”: ‘cioè un i sono giovane allegro e beffardo, chiamato così sia perché si prodiga in scherzi, soprattutto con le donne che “stanno al gioco”, sia perché passano, spassano e ripassano più volte nella stessa “strada”. (fisica e/o comportamentale); conosciutissimi, ia tal proposito,, sono i versi composti da Giuseppe Capaldo di “‘A tazza ‘e café” che sarebbero stati ispirati dalla bella ma scorbutica Brigida, cassiera del Caffè Portorico di Napoli (cfr. un mio vecchio post).
Si dice che Giuseppe Capaldo compose, in pochissimi minuti, i versi della canzone, poi musicata da Vittorio Fassone; la canzone fu pubblicata nel 1918. Con un andamento musicale allegro e un testo ricco di sottintesi, “A tazza ‘e café” è un quadretto popolaresco ben riuscito che descrive un battibecco amoroso. In realtà, dietro questa contesa dialettica si nasconde la celebrazione di un vero e proprio “culto napoletano>: quello di un vero e prorpio rito, di un “filtro d’amore” che serba il dolce sul fondo.
* I versi
Ecco il testo della canzone ‘A tazza ‘e cafè, correttamente compilata:
Vurría sapé pecché si mme vedite,
facite sempe ‘a faccia amariggiata…
Ma vuje, quanto cchiù brutta ve facite,
cchiù bella, a ll’uocchie mieje, v’appresentate…
I’ mo nun saccio si ve n’accurgite! …
Ma cu sti mode, oje Bríggeta, tazza ‘e café parite:
sotto tenite ‘o zzuccaro, e ‘ncoppa, amara site…
Ma i’ tanto ch’aggi”a vutá, e tanto ch’aggi”a girá…
ca ‘o ddoce ‘e sott’â tazza, fin’a ‘mmocca mm’ha da arrivá!…
Cchiù tiempo passa e cchiù v’arrefreddate, ‘
mméce ‘e ve riscaldá…”Caffè squisito!…”
‘o bbello è ca, si pure ve gelate,
site ‘a delizia d”o ccafé granito…
Facenno cuncurrenza â limunata…
…
Vuje site ‘a mamma d”e rrepassatore?… E ij, bellezza mia, figlio ‘e cartaro!…
Si vuje ve divertite a cagná core,
ji’ faccio ‘e ccarte pe’ senza denare…
Bella pareglia fóssemo a fá ammore!
facite sempe ‘a faccia amariggiata…
Ma vuje, quanto cchiù brutta ve facite,
cchiù bella, a ll’uocchie mieje, v’appresentate…
I’ mo nun saccio si ve n’accurgite! …
Ma cu sti mode, oje Bríggeta, tazza ‘e café parite:
sotto tenite ‘o zzuccaro, e ‘ncoppa, amara site…
Ma i’ tanto ch’aggi”a vutá, e tanto ch’aggi”a girá…
ca ‘o ddoce ‘e sott’â tazza, fin’a ‘mmocca mm’ha da arrivá!…
Cchiù tiempo passa e cchiù v’arrefreddate, ‘
mméce ‘e ve riscaldá…”Caffè squisito!…”
‘o bbello è ca, si pure ve gelate,
site ‘a delizia d”o ccafé granito…
Facenno cuncurrenza â limunata…
…
Vuje site ‘a mamma d”e rrepassatore?… E ij, bellezza mia, figlio ‘e cartaro!…
Si vuje ve divertite a cagná core,
ji’ faccio ‘e ccarte pe’ senza denare…
Bella pareglia fóssemo a fá ammore!
Tra le tante, scelgo tre parole per la mia analisi, aiutata dai testi di Carlo Iandolo e Raffaele Bracale;
§ Café; a Napoli si scrive rigorosamente con una f (cfr. le regole in appendice);
§ Cartaro è espressione mutuata dal gioco delle carte e il senso comune è distribuire le carte, fare le carte (come fa anche un/una cartomante). Fare il cartaro non piace a chi ama comandare, che nel gioco pretenderebbe di esser sempre servito di carte, piuttosto che farle, per poter poi iniziare la partita a modo suo. In senso più ampio, quindi, sta per restìo: nun vo’ fà carte una ragazza che rifiuti le avances di un corteggiatore, un genitore che rifiuti di soddisfare le eccessive richieste di danaro d’un figliolo, o moglie che non vuole cucinare un piatto elaborato.
Nel caso specifico della canzone, ‘o figlio ’e cartaro, forte dell’esperienza del padre, vuole controllare se c’è dietro le beffe sostanza o non;
§ Fà ‘e carte pe’ senza denare: come senza interessi personali;
§ ‘Mmocca, letteralmente in bocca: la preposizione semplice “in” nel napoletano viene agglutinata al sostantivo che segue;
§ Pareglia, coppia;
§ Rrepassatore, letteralmente “che ripassa”, che in italiano indica l’artigiano o l’operaio che “ripassa””, cioè controlla, il suo lavoro; molto diverso. il rrepassà (o arrepassà) napoletano, che è atteggiamento di scherno, presa in giro, “vuje site ‘a mamma de’ arrepassatore” “voi siete maestra negli scherni e nelle prese in giro”. Deriva dall’italiano “ripassare” inteso come percossa, ammonizione.
Le regole dell’autentico “café napulitano”
1) Amore: il caffè, a dispetto di ogni canone, sarà ‘na ciofeca’ (come diceva Totò) se non lo si prepara con l’amore;
2) Acqua: l’acqua napoletana, per le sue caratteristiche chimico-fisiche, è determinante per la qualità ed il sapore del caffè;
3) Rito: per i Napoletani bere un caffè costituisce vero e proprio rito, che induce alle riflessioni e -possibilmente- va condiviso con gli amici. Perché “bere il caffè da soli ‘è il massimo della solitudine’” (Massimo Troisi in “Scusate il ritardo”).
4) Tempo atmosferico: il clima mite agevolano il compito dei baristi napoletani di individuare il giusto punto di macinatura: la polvere di caffè non deve essere né molto fine né grossa, altrimenti non si ottiene il gusto ottimale;
5) La miscela della tradizione napoletana è preferibilmente un misto di due qualità: l’arabica e la robusta. L’arabica, più dolce e fruttata; la robusta più forte e corposa; occorre un giusto equilibrio tra le due specie, che devono avere in più una tostatura, scura e prolungata;
6) Il caffè va bevuto appena fouriesce dalla caffettiera: i baristi napoletani usano l’epressione “a coda ‘e zoccola“, cioè lasciando (come disse un barista del Gambrinus) una scia liquida man mano più sottile, dal rubinetto alla tazzina.
7) “25 secondi” è il tempo della fuoruscita del caffè dalla macchinetta alla bocca del gustatore;
8) Bicchiere d’acqua. Nell’attesa del caffè è obbligatorio bere un bicchiere d’acqua fresca, perché “pulire” la bocca è fondamentale prima d’assaporare al meglio l’espresso.
9) Tazza calda. La tazzina deve essere calda come il caffè appena estratto; altrimenti la bevanda subisce uno shock termico che potrebbe alterarne aroma e gusto Un vecchio detto napoletano impone le regole precise “delle tre c”, vale a dire: “Cazzo, comme coce!”
10) Colore: la regola fu recitata da Sophia Loren nel film Questi fantasmi del 1967, (rifacimento cinematografico dalla commedia eduardiana). “‘O culore? “A manto ‘e monaco” cioè il marrone del saio dei monaci francescani”.
Per finire, parliamo di gentilezza partenopea: la consuetudine (che purtroppo si va perdendo) consiste nel generoso gesto di pagare un caffè ad uno sconosciuto. Se chiamma “caffè sospeso”, descritto sagacemente da Luciano De Crescenzo: “Quando un napoletano è felice per qualche ragione, decide di offrire un caffè ad uno sconosciuto perché è come se offrisse un caffè al resto del mondo“.
I principali interpreti delle canzoni su ‘O cafè.
Ad una prima canzone napoletana dedicata al caffè nel 1891, “‘A cafettèra” ormai sconosciuta (1918, versi di Giuseppe Capaldo e musica del cavalier Vittorio Fassone) seguì l’interpretazione della famosa “‘A tazza ‘e cafè”” di Elvira Donnarumma; di questa canzone ci sono le versioni Roberto Murolo, Nicola Arigliano, Sergio Bruni Angela Luce, Massimo Ranieri, Maria Nazionale e Lina Sastri.
Fonti
Pagina Facebook Etimologia delle parole napoletane
(Dai miei vecchi post e dall’articolo “Le dieci regole del caffè napoletano> della rivista “l’Espresso napoletano”, settembre 2019 dedicato a Raffaele Viviani, modificato, l’immagine: la copertina della canzone “‘A tazza ‘e cafè”)